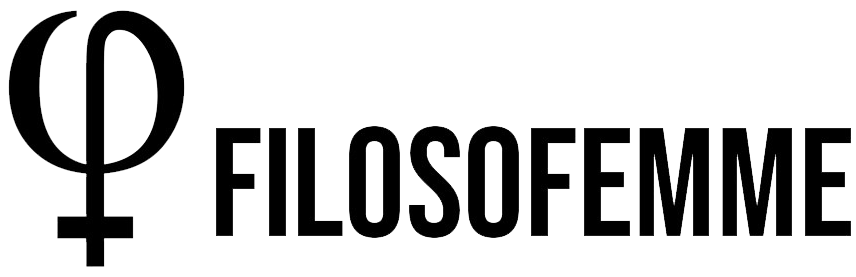Nel terzo capitolo del saggio del 1958 Vita Activa. La condizione umana (1) Hannah Arendt analizza l’attività del lavoro, la prima delle tre che caratterizzano la condizione umana, inquadrata dalla filosofa nelle coordinate di pensiero della scuola heideggeriana.
La prima definizione di essere umano ad essere proposta è quella di animal laborans, relativa all’attività del lavoro.
Si tratta della sfera più intima dell’uomo, facente riferimento all’insieme dei processi corporei che scandiscono il ciclo vitale: il lavoro rientra quindi a far parte del regno della necessità, in quanto attività da cui l’uomo non può liberarsi per poter soddisfare i propri bisogni vitali. Nonostante la generale confusione, l’opera, al contrario del lavoro, emerge piuttosto dal dominio della non-naturalità dell’esistenza umana, dando vita al mondo artificiale degli oggetti, dimora di ogni vita individuale.
L’homo faber che fa, che modella e crea, in contrapposizione all’animal laborans che soffre e si sottomette alla necessità: il grande qui pro quo figlio della modernità risiede nell’uso improprio a livello linguistico e concettuale dei prodotti dell’opera e di quelli del lavoro, cosicché gli uni siano scambiati per gli altri, creando delle contraddizioni teoriche non indifferenti. Se il mondo dell’opera e dell’artificio è segnato dalla durabilità e della permanenza nel mondo, i prodotti del lavoro sono marchiati dall’intangibilità e dall’essere costantemente rigettati nel processo ciclico della vita biologica, ritmata dal soddisfacimento dei bisogni e delle funzioni primarie.
L’era moderna diventa quindi luogo di scambio tra i prodotti dell’opera e quelli del lavoro: gli ideali della stabilità e della durabilità dell’homo faber, artefice primario di un mondo di oggetti d’uso, sono sacrificati sull’altare dell’abbondanza sacro all’animal laborans, in modo che ogni prodotto destinato all’uso diventi al contrario oggetto di consumazione, fino a rendere del tutto insignificante la differenza tra utilizzo e consumo. L’ascesa del lavoro al primo rango nella moderna società di massa, a partire dalla posizione più disprezzata nell’Antichità, determina quindi il ribaltamento della gerarchia classica delle facoltà umane, incrementando il rischio della scomparsa della sfera politica tramite la vittoria degli ideali che relegano l’uomo alla sfera intima e privata del suo corpo, schiavo delle proprie necessità vitali e in balia del processo incessante di produzione-consumazione.
È attraverso una rilettura critica dell’opera di Marx e degli economisti classici che Arendt determina innanzitutto una linea di demarcazione netta tra l’attività del lavoro e quella dell’opera, per mostrare il ruolo centrale della prima nel processo di produzione e consumo della moderna cultura di massa.
L’interesse della filosofa per l’estraneità del lavoro rispetto al mondo va nella direzione di una critica profonda al nuovo modello di società, dove l’imporsi delle masse di lavoratori – o consumatori – ha sancito il trionfo dell’animal laborans sulla mentalità dell’homo faber: la società moderna vede il raggiungimento della totale reclusione dell’uomo su sé stesso, vincolato dal soddisfacimento delle proprie funzioni biologiche e naturali. È così che la modernità si staglia sullo sfondo del carattere distruttivo e divorante dei processi naturali da una lato e dall’altro l’abbondanza dei prodotti e la fecondità illimitata delle forze produttive.
Nonostante la confusione tra i prodotti del lavoro e quelli dell’opera, a segnalare un primo legame dei primi con il processo biologico della vita è lo stesso Marx attraverso la messa in luce del carattere produttivo del lavoro, considerato nel Capitale come “consumazione produttiva”.
A partire da una definizione del lavoro come una «necessità naturale eterna, mediazione indispensabile al metabolismo che si produce tra l’uomo e la natura, e quindi alla vita umana (2)», in cui ogni prodotto è fatto per essere immediatamente consumato, Marx sottolinea che la sua produttività risiede nella possibilità di moltiplicare all’infinito i mezzi di sussistenza in modo da garantire la sopravvivenza della specie. Il metro di giudizio di cui si avvale Marx prevede però un totale ribaltamento della mentalità classica: se l’antichità prevedeva la distinzione tra i cittadini liberi e gli schiavi sulla base del fatto che questi lavoravano per vivere e per far vivere il proprio padrone, la modernità con Marx si rende complice dell’ascensione spettacolare e improvvisa del lavoro al primo posto tra le attività umane.
Secondo l’analisi di Arendt la lacuna teorica di Marx riguarda quindi il problema «di un’esistenza separata dagli oggetti-del-mondo la cui durabilità resiste e sopravvive ai processi divoranti della vita (3)», a cui l’uomo è condannato nel momento in cui ogni cosa diventa oggetto di consumazione destinato all’immediato assorbimento per la soddisfazione dei bisogni naturali.
Da una totale sfiducia nei confronti del lavoro l’uomo moderno approda quindi alla sua esaltazione e glorificazione sull’altare della produttività: con l’azzeramento della durata degli oggetti d’uso e la loro incessante produzione di massa, la società assiste al trionfo della necessità. Gli esseri umani non sono che degli individui isolati nei loro corpi, totalmente passivi rispetto alla loro vita biologica e privati della loro appartenenza-al-mondo, al punto da vedersi preclusa la possibilità di entrare in contatto con l’altro tramite la parola e l’azione.
L’animal laborans è infatti l’essere apolitico e antipolitico per eccellenza, destinato a una condizione di cattività e schiavitù che gli rendono impossibile la comunicazione e la condivisione.
Nel panorama delle ricerche sociologiche e politiche sull’esperienza dei regimi totalitari, è quindi nell’incapacità dell’uomo moderno, schiavo delle sue necessità, di fondare una realtà comune dove ciascuno possa esprimere la propria identità che va ricercata l’origine dell’attuale società di massa, dominata dalla consumazione a un ritmo divorante e ripetitivo.
D’altra parte, il nucleo argomentativo di Arendt trova posto anche nella nostra contemporaneità, ponendosi sullo sfondo dell’automatizzazione del lavoro figlia del progresso tecnologico.
Se lo sviluppo e il perfezionamento delle macchine sembrano aprire la strada alla liberazione dalla fatica a cui il lavoro è sempre stato associato, in realtà il suo carattere intrinsecamente necessario resta anche oggi un’invariante. La tecnologia, infatti, non si pone come un antidoto al giogo della necessità imposta dal fatto di avere un corpo, ma non fa che ridurre al minimo la distanza tra produzione e consumazione in modo da dar vita a un mondo in cui ogni cosa è destinata sin dalla sua comparsa al deperimento, salvo la sua inclusione nel ciclo delirante dell’economia dello spreco. L’abbondanza e lo spreco vanno di pari passo con la distruzione del pianeta attraverso l’intensificazione di un’economia sempre più insostenibile.
La conferma della previsione di Arendt ci è data dalla constatazione che l’uomo, piuttosto che liberarsi dal giogo fatale del lavoro e uscire dal suo stato di alienazione grazie allo sviluppo tecnologico, come vorrebbe Marx, assume al contrario una posizione sempre più servile nei confronti delle stesse tecnologie che crede di poter controllare: attraverso l’uso massivo degli apparecchi elettronici l’uomo non solo non deve più fare fatica, deformando il suo corpo in pesanti attività lavorative, ma non è neanche più costretto a pensare, liberandosi anche di ciò che lo rende veramente umano.
(1) Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano, 2017. I ed. originale 1958.
(2) Karl Marx, Das Kapital, 1867.(3) Hannah Arendt, The Human Condition, 1958.
-
Il soffocante concetto di merito
5 Dicembre 2022 -
Game of Thrones e le donne
27 Dicembre 2019 -
La società della fiducia. Da Platone a Whatsapp
9 Ottobre 2020
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy