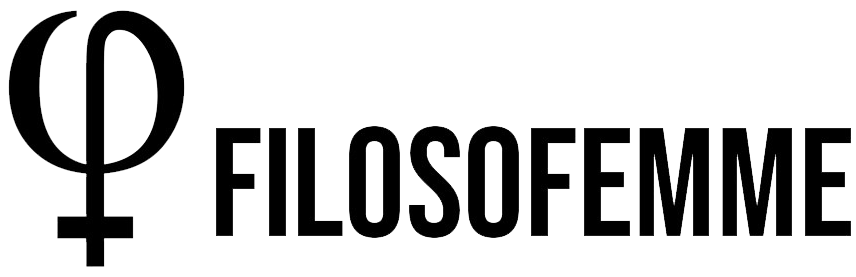La scrittura, dacché è stata scoperta, ha avuto il ruolo fondamentale di imprimere su un supporto (cartaceo e non) il nostro quotidiano, i nostri pensieri e ricordi. Questo strumento si è da sempre scontrato con il suo opposto: l’oralità.
Scrivere o non scrivere? Qual è il mezzo migliore affinché le nostre storie perpetuino e non vadano perse? Numerosi testi dal valore inestimabile, biblioteche e volumi sono stati bruciati, manipolati o andati perduti, così come il loro contenuto. La tradizione orale ha invece tramandato, di generazione in generazione, gli usi e costumi di un popolo, giungendoci più o meno intatti e fedeli agli originali. Si pensi ai trobadore, i quali, tramite la figura dei menestrelli, decantavano storie e canzoni d’amore. Grazie alle numerose ripetizioni e all’utilizzo di un refrain, questi lunghi racconti erano facilmente memorizzabili. La mitologia nordica è giunta a noi, ad esempio, grazie ai racconti orali – finché non intervenne Snorri Sturluson, che mise per iscritto per la prima volta nella sua Edda tutto il sapere scandinavo. I particolari nomi di alcuni personaggi non erano che giochi di parole con i precedenti, così da agevolarne l’apprendimento.
Prima ancora di questi esempi storici, già Platone era arrivato a discorrere su questa dualità così come Socrate, il quale decise di non ricorrere alla scrittura per trasmettere il suo pensiero filosofico, ma prediligendo il dialogo nell’agorà. Il mito di Theuth, presente nel Fedro, è nello specifico un resoconto esaustivo del pensiero platonico. Questo racconto, purtroppo poco conosciuto dai più, narra l’incontro tra Theuth, dio egizio inventore della scrittura, e Thamus, re degli Egiziani. La divinità accorre presso la corte del sovrano per mostrargli i servigi offerti dalla sua invenzione:
Arrivato alle lettere dell’alfabeto, Theuth disse: “Questa conoscenza, mio re, renderà gli Egiziani più sapienti e più capaci di ricordare: memoria e scienza hanno trovato il loro farmaco”. [1]
Il sovrano, allora, che qui impersonifica il pensiero platonico, apostrofa il dio, sostenendo che la scrittura svolge l’esatto contrario di quanto detto:
«Tu che sei il padre delle lettere, per troppa benevolenza hai attribuito loro effetti contrari a quelli che hanno. Questa conoscenza infatti farà calare l’oblio sulle anime di chi l’apprende, trascurando l’esercizio della memoria; perché confidando nella scrittura non eserciteranno più la memoria dall’interno di se stessi ma dall’esterno, da caratteri estranei: hai trovato insomma un farmaco non per la memoria ma per richiamare alla memoria”». [2]
Richiamare alla memoria: è questo il ruolo che ha effettivamente la scrittura, paragonabile – in quanto imperfezione – alla pittura. Meri artifici che se interrogati tacciono, nonostante alla vista possano sembrare reali. Questi non sono che copie delle copie e i discorsi, così come quelli scritti, non sono che immagini (eidōlon) di un discorso più grande insito nell’anima e frutto della conoscenza.
A questo punto sorge dunque il dubbio del perché Platone abbia comunque deciso di scrivere i suoi famosi dialoghi, anziché seguire l’esempio del suo maestro. Il filosofo non cade tuttavia in contraddizione e tramite questo mito non fa che trattare un discorso molto sentito dalla sua epoca. Il suo insegnamento è quello di operare con l’ausilio sia dell’oralità che della scrittura , senza che una prevalga sull’altra. Entrambe hanno dei limiti, in virtù del loro essere copie di modelli perfetti e impraticabili per l’uomo. Non resta che accettare questa costante tensione umana verso il vano superamento dei propri difetti, mirando nonostante tutto ad una conoscenza sana e il meno possibile ingabbiata dall’errore.
[1] Fedro, 274e-275a
[2] Ibidem.
FONTI
Platone, Fedro, tr. it. a cura di M. Bonazzi, Einaudi, Torino 2011.
http://classicamente-dora.blogspot.com/2010/05/lorigine-della-scrittura-secondo.html
Abel, il pistolero di Baricco che legge Hume
21 Aprile 2024L’uso “socratico” di ChatGPT
15 Maggio 2023L’utilità dell’amore a senso unico
25 Maggio 2022
-
Storie di genere. Il punto sulle donne
25 Marzo 2022 -
Sei proprio un maiale!
27 Agosto 2018 -
Questo libro è trans
11 Giugno 2021
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy