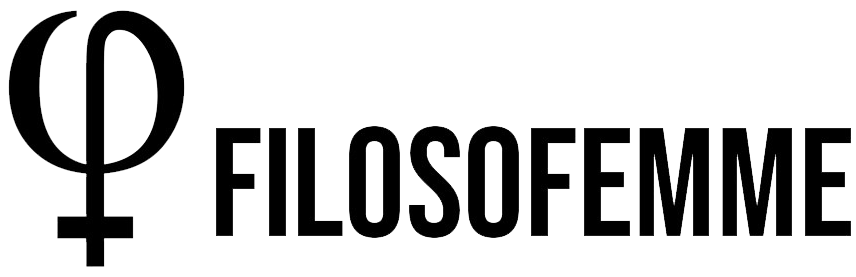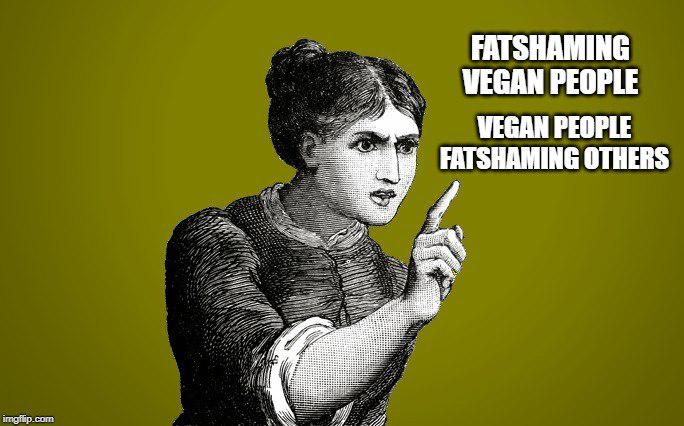XXI secolo: epoca della diversità, della multi-etnia e della mescolanza.
Ci troviamo a vivere, volenti o nolenti, nella culla di scambi, sfaccettature cromatiche, culinarie e culturali, di scoperte ed esplorazioni; ma inevitabilmente anche di scontri, discriminazioni e violenze.
Che ruolo può avere la traduzione linguistica in tutto questo? Rimanere relegata all’aspetto letterario oppure, affacciandosi a livello teorico e pratico all’attualità, intervenire sul problema culturale e quotidiano dell’alterità, del contatto con lo straniero e della pluralità linguistica?
Avvicinandoci al pensiero del filosofo francese novecentesco Paul Ricœur e alla sua filosofia etica, osserviamo questa corrente di ricerca affiancarsi efficacemente alla teoria generale della traduzione linguistica, per poi sfociare in un vero e proprio studio sulla diversità. Vediamo come.
Soprattutto negli ultimi anni, la filosofia etica ha sviluppato i suoi studi nel campo della traduzione partendo dalla sua presunta condizione ancillare. Tale condizione, agli occhi del pubblico oltre che a quelli dei traduttori stessi, risulta spesso anche sospetta dovendo «servire due padroni»: la lingua originale dell’opera (quella straniera) e la lingua in cui dovrà essere tradotta (quella di traduttore e pubblico). Il filosofo Ricœur sostiene al riguardo che il traduttore si trovi all’interno di un dilemma che non comporti l’alternativa tra traducibile ed intraducibile, bensì quella tra fedeltà e tradimento, di cui si parlerà in seguito.
Afferma innanzitutto che non si traduca propriamente una lingua, ma si traduca da una lingua all’altra, quindi solamente il discorso può permettere tale passaggio e la traducibilità è da considerarsi perciò qualità “mediativa”. Essa è esperienza dell’altro e non sua negazione: è esperienza del proprio non-essere. È Bildung, «formazione», in quanto l’estraneo ha funzione mediatrice e il linguaggio è mezzo universale per la comprensione intersoggettiva: esso è ambiente, come sostiene il pensatore tedesco Schleiermacher, non strumento.
Ricœur ritiene, dunque, il linguaggio un modello intorno al quale si possa costruire una concreta etica dell’ospitalità e della fratellanza, essendo la lingua elemento fondante sia per quanto riguarda l’essere umano, sia per quanto riguarda i rapporti sociali. Nella sua trattazione, il filosofo parte da un’interpretazione del mito di Babele definendolo un enigma, secondo alcuni focalizzato sul tema della «dispersione» e della «confusione» geografica e comunicativa. Ciò comporta successivamente la frequente negazione dell’universalità del linguaggio (tutti gli uomini parlano) a causa della sua «frantumazione» tra vari paesi ed etnie. Ricœur, nel tentativo di contrastare questa idea, dopo aver evidenziato l’universalità incontrovertibile del linguaggio, continua sostenendo che «si è sempre tradotto», quindi la capacità di imparare e praticare altre lingue oltre la propria è parte integrante dell’individuo. Il linguaggio è lumen naturale che “illumina” ogni essere umano e gli permette di “essere visibile” all’interno del mondo: esso non esiste al di fuori di una pluralità. Ricœur interpreta quindi il mito di Babele seguendo un punto di vista ottimista riguardo la condizione umana: Babele è per lui non simbolo di catastrofe, bensì origine di un progetto di fratellanza.
È proprio qui che si trova la questione dell’alternativa tra fedeltà e tradimento, scheletro del paradigma della traduzione di Ricœur: esso deve fungere da modello nell’atto di tradurre, basandosi sull’idea di ospitalità linguistica, strada interna alla diversità per la quale consapevolmente si servono e/o tradiscono due padroni. Questo comporta la necessità di abbandonare la pretesa di una traduzione perfetta, quasi violenta e alienante, tipica di un assolutismo linguistico, e di cercare invece la cosiddetta «felicità di tradurre» tramite l’accettazione della coppia proprio/straniero. In traduzione quindi è possibile raggiungere, tra due lingue, una equivalenza senza identità. È utile citare al riguardo le parole della filosofa Barbara Cassin: «Si inventa stando tra due lingue. È ciò che si chiama tradurre. L’uomo non è un animale dotato di logos, è un animale poliglotta».

L’atto traduttivo è dunque atto d’esperienza, pulsione naturale dell’essere umano che ha sempre vissuto a contatto con l’estraneo. Il traduttore rappresenta la sua intera comunità in rapporto con quella originaria dell’opera cui si approccia, l’altra con cui si cerca un contatto, un punto in comune. La traduzione è autonoma, sopravvive all’interno di una visione d’illuminazione e arricchimento da parte di altre pratiche e saperi.
Il linguaggio deve essere abitato, per dirla con i Romantici. Il cuore dello scambio e della traduzione linguistica sta proprio nella diversità delle lingue, segno di un’umanità sfaccettata: la pulsione del lavoro traduttivo si direziona quindi tanto verso la volontà di appropriazione dell’altro, quanto verso l’accoglienza della sua diversità.
Ricœur crea quindi una regola di giustizia con la sua teoria linguistica: sostiene infatti che tradurre significhi rendere giustizia al genio straniero, la cui lingua deve essere riconosciuta e accettata proprio in quanto differente. Essa è modo d’essere e pensiero di un popolo, e la traduzione sarà perciò tramite di svelamento della totalità di una cultura racchiusa in quella lingua.
La frammentazione dell’umanità e dei suoi svariati idiomi deve essere vista nel segno di una storia unitaria dei popoli, operando un lavoro altruistico, rispettoso, onesto ed umile.
FONTI
Berman A., La prova dell’estraneo. Cultura e tradizione nella Germania romantica, trad. it. di Giometti G., Quodlibet, Macerata 1997.
Cassin B., La nostalgia. Quando dunque si è a casa? Ulisse, Enea, Arendt, trad. it. di Peduzzi A.C., Moretti&Vitali, Bergamo 2015.
Jervolino D., Per una filosofia della traduzione, Editrice Morcelliana, Brescia 2008.
Ricœur P., Tradurre l’intraducibile. Sulla traduzione, trad. it. di Oliva M., Urbaniana University Press, Roma 2008.
-
Vegan, non #fit
7 Agosto 2019 -
Parole mie con voce tua
4 Dicembre 2020 -
Poliamore: l’amore si moltiplica
29 Aprile 2020
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy