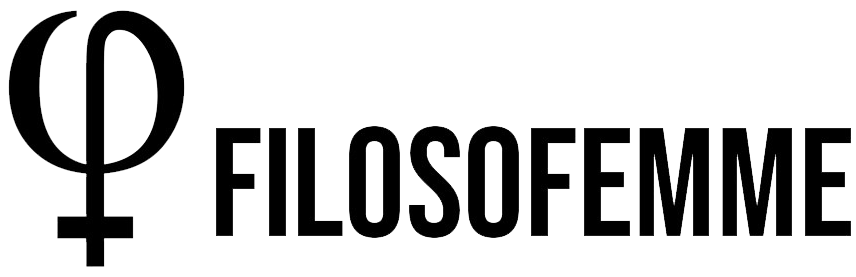Gli studi sul mondo del lavoro si intrecciano con i cosiddetti gender studies: approcci trans-disciplinari che concentrano l’attenzione sulle pratiche legate alla sessualità e all’identità di genere e sui significati delle stesse. Gayle Rubin (1) ha definito sex-gender system l’insieme dei comportamenti e delle relazioni con cui la società organizza la divisione dei compiti tra uomini e donne, creando appunto il genere. È bene, allora, sottolineare che il termine indica l’insieme di uomini, donne e delle loro relazioni: riferirlo solo alle donne spoglierebbe il concetto della sua ricchezza.
Nel mondo del lavoro la questione del genere è passata per molto tempo sotto silenzio: fino agli anni Sessanta, la questione della relazione tra donne e uomini negli ambienti lavorativi è stata, di fatto, un non concetto.
L’ingresso delle donne, per lo più scolarizzate, nel mondo del lavoro era cosa recente e nessuno si domandava il perché non ricoprissero cariche manageriali. L’invisibilità della loro presenza – è un’espressione paradossale, ma di questo si tratta – ha comportato l’adesione acritica delle imprese a un paradigma organizzativo maschile, modellato sulle esigenze degli uomini. Tra gli anni Settanta e Ottanta si inizia a prendere coscienza della presenza femminile eccezionale (nel senso letterale del termine) nel mercato e a sentire la necessità di tematizzarla. Perché le questioni di genere trovino ampio spazio nella letteratura sugli studi organizzativi, bisogna attendere gli anni Novanta: rassegne, riviste e pubblicazioni contribuiscono a evidenziare come i confini tra il mondo produttivo/professionale – in cui orbitavano gli uomini – e il mondo riproduttivo/familiare – riservato alle donne – stessero diventando sempre più labili.
Di conseguenza, il problema della conciliazione tra lavoro e famiglia – storicamente considerato appannaggio femminile – coinvolge anche la sfera maschile; in concomitanza le donne iniziano a sentirsi in diritto di accedere a posizioni di responsabilità. Se veniva dato per scontato che le donne dovessero ricoprire ruoli di cura, per un bisogno di presenza in famiglia attribuito solo a loro (non potendo, perciò, dedicare tempo sufficiente all’azienda assentandosi da casa), oggi si ragiona anche sul ruolo paterno, che subiva discriminazione uguale e contraria al ruolo della donna: l’una nel mondo lavorativo, l’altro nel mondo familiare.
A cosa si devono le credenze che scindono uomini e donne in due universi paralleli?
Simone de Beauvoir (2), ne Il secondo sesso, sostiene che esista una profonda differenza tra essere donna ed essere femmina: non c’è alcun nesso tra le due condizioni. Essere femmina significa appartenere a un certo sesso ed è un presupposto biologico; essere donna è, invece, una condizione determinata dal contesto sociale e culturale di riferimento. In altri termini, il sesso di un essere umano non fissa il suo destino e la biologia non determina la vita di donne e uomini. Il genere è allora frutto di interazioni sociali, di relazioni di potere tra uomini e donne ed è separato dal ruolo biologico.
Al contrario, un approccio biologico alla questione del genere apriva numerose strade alla discriminazione. Esso stabilisce in maniera deterministica che le persone possiedano determinate predisposizioni e abilità sulla base della loro appartenenza biologica. Ad esempio, il cervello maschile è ritenuto programmato per capacità di azione; in quello femminile prevarrebbero qualità inerenti alla dimensione relazionale. Ne deriva che i ruoli ricoperti sono rispettivamente decisionali e dirigenziali da un lato, di servizio, di cura e con minore responsabilità dall’altro.
L’approccio socioculturale – appoggiato da diversi antropologi e antropologhe, tra cui Margaret Mead (3) – riconosce invece una costruzione (e costrizione) sociale e culturale nell’attribuzione a uomini e donne dei ruoli nel lavoro, nella società e nella famiglia. È con i processi di socializzazione che un corpo maschile e un corpo femminile assumono il ruolo di “uomo” e “donna”. Attraverso l’assimilazione di comportamenti ritenuti corretti, si sviluppa sin da bambini l’idea che vi siano atteggiamenti e condotte adatti a un sesso e non all’altro. Ecco perché per molto tempo l’uomo è stato il breadwinner – quello che porta a casa il pane – mentre la donna si occupava del lavoro di cura del nucleo familiare.
Ad oggi, la donna ricopre un ruolo trasversale; eppure ancora non si può parlare di una completa parità di trattamento nel mercato e nel contesto lavorativo.
Come si manifesta la cultura organizzativa gendered?
Nella nostra contemporaneità, sono ancora molti – troppi – i casi in cui a un colloquio di lavoro viene chiesto alle donne se sono sposate, se sono madri e in tal caso come pensano di gestire la maternità e la famiglia – peraltro violando la privacy di quelli che sono classificabili come dati sensibili, ininfluenti rispetto alla valutazione della qualità di un’eventuale prestazione lavorativa. L’attribuzione dell’esigenza solo femminile di essere presenti in famiglia impedisce spesso l’assunzione per mansioni di responsabilità, creando il fenomeno del soffitto di cristallo: una barriera trasparente, da cui la donna può guardare un obiettivo, ma non può raggiungerlo. In concomitanza, si assiste alla terziarizzazione del lavoro femminile, dove si intende in particolare la limitazione occupazionale a segmenti professionali di cura e servizio, tendenzialmente con scarso riconoscimento economico e professionale. Anche là dove vengano raggiunte posizioni manageriali o di alto livello, a parità di competenze accade, che la ricompensa non sia paritaria tra uomini e donne.
Questi sono solo i sintomi più evidenti della disparità e della coercizione. Le società e le organizzazioni producono simboli e immagini più sottili che indicano le relazioni di potere tra i due sessi, a partire dai codici di abbigliamento, fino al linguaggio concesso agli uni e alle altre e in quello utilizzato in azienda. Il linguaggio che caratterizza l’organizzazione lavorativa è definito, infatti, agentic – composto cioè da verbi e immagini di azione, proprio quella caratteristica ritenuta a lungo propria del maschio/uomo.
Quali sono le conseguenze di una cultura organizzativa gendered?
Le donne che vedono sminuire la desiderabilità e la remunerazione del proprio ruolo lavorativo sperimentano un senso di alienazione, una percezione ambigua della propria presenza in azienda e da ciò conseguono alcune reazioni: accettare il compromesso implicito che stabilisce quali ruoli possano ricoprire e per quali “non sono adatte”, altre volte escono dal mercato del lavoro, giustificando tale uscita con il desiderio di dedicarsi alla famiglia. In alternativa, scelgono di investire nella professione, accettando la quantità stabilita di tempo in presenza (il cosiddetto face time, non valutato in termini di qualità), dando disponibilità a trasferte e viaggi, adattandosi alle regole stabilite per gli uomini in nome di una presunta parità. Viene da sé che ciò non è facilmente compatibile con la possibilità di avere una famiglia.
I meccanismi gendered, in altri termini, sono assimilati al punto da ritenere normale la scelta tra la carriera e gli affetti, al punto che le stesse donne, avendo interiorizzato valori propri di una logica lavorativa maschile, si autolimitano nelle scelte. Tuttavia, anche gli uomini rimangono vittime di questa cultura: sono privilegiati nell’accesso alla carriera, ma lamentano scarso tempo trascorso in famiglia. Non sarebbe più equo un contesto che non portasse nessuno a dover scegliere tra la propria realizzazione professionale e quella personale?
Esiste una soluzione?
Con tutta probabilità, una possibile soluzione risiede in una revisione culturale, nella ricerca a monte del problema anziché nei soli tentativi pratici a valle. Alcune prospettive dei gender studies possono venire in aiuto.
La fase più recente dei gender studies è caratterizzata dalle teorie post-strutturaliste e dalla teoria queer: Judith Butler (4) è una delle filosofe che hanno contribuito a rivedere l’idea di identità sessuale e di genere. Il genere è definito queer: è strano, indeterminato, fluido. Butler elabora allora la nozione di performatività del genere, secondo cui esso viene costruito dal linguaggio: dal momento in cui si pronuncia, alla nascita, “è maschio”/ “è femmina” si dà avvio a una catena di atti performativi che portano il soggetto a diventare uomo o donna e si presuppone che adeguerà a queste categorie il proprio comportamento. Si genera in questo modo una forma di normalità e di normatività, che possiedono una dimensione di violenza limitatoria sui progetti di vita. Normalità e normatività del mondo lavorativo comportano stereotipi di genere che sfociano non solo in più o meno sottili discriminazioni tra uomini e donne in quanto tali, ma anche sui loro gusti sessuali: nella cosiddetta eteronormatività. Ne deriva una catena viziosa: “ci si aspetta” che l’eterosessualità sia la normale espressione delle relazioni tra uomini e donne, dunque che il comportamento degli individui sia valutato sulla base di norme pensate per eterosessuali e che coloro che non si sentono compresi nella norma vivano il contesto lavorativo con la pressione di non essere adatti. Un po’ come non era/è considerata adatta la donna per le posizioni manageriali.
La prospettiva WIM (Women In Management) parte dall’analisi dei fenomeni discriminatori per proporre due modelli complementari: il modello dell’uguaglianza (di trattamento) e il modello della differenza (dei soggetti). Succede spesso che la reazione del mondo femminile alle discriminazioni in ambito lavorativo sia quella di rivendicare il possesso di uguali competenze rispetto agli uomini e di conseguenza un uguale trattamento (stipendio, accesso alla carriera). Il concetto di pari opportunità, tuttavia, non presuppone uguaglianza. Auspica sì un trattamento egualitario, ma proprio in virtù delle differenti competenze che donne e uomini possiedono. Ciascun individuo apporta all’azienda un contributo in maniera diversa e di ugual valore.
Solo la presa di coscienza delle dinamiche di genere che spesso governano le realtà organizzative, dell’abbandono di costrizione culturale insito nel concetto di performatività del genere e della ricchezza che la diversità apporta in termini di prestazioni lavorative, può spianare la strada all’uguaglianza di trattamento.
(1) Antropologa statunitense, conosciuta come attivista e teorica in ambito di studi di sessualità e genere.
(2) Scrittrice, insegnante e filosofa esistenzialista francese; compare tra le eroine femministe di Lisa Simpson.
(3) Antropologa statunitense, famosa per le proprie ricerche nelle isole Samoa.
(4) Filosofa post-strutturalista statunitense. Si occupa di filosofia politica, etica, teoria letteraria, femminismo e teoria queer. Insegna all’Università di Berkeley.
Fonte: P. Argentero, C.G. Cortese, Psicologia delle organizzazioni, Raffaello Cortina editore, Milano, 2018.
Un’altra cena rovinata
25 Luglio 2024Blanchard vs. Blanchard: un matricidio moderno
21 Luglio 2024Il pozzo della solitudine
19 Luglio 2024
-
Libertà come presupposto d’Amore
31 Maggio 2021 -
Problemi. Una guida per capire l’assurdità del presente
21 Luglio 2023 -
Gillette e il femminismo pop
20 Gennaio 2019
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy