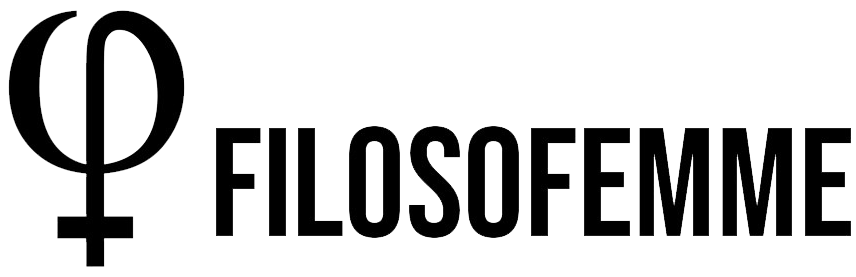notre dame martina peruzza
La sera del 15 aprile ero appena rientrata a casa dopo un consueto lunedì in ufficio, quando ho saputo di Notre-Dame in fiamme.
Caso vuole che da qualche mese io mi trovi proprio a Parigi, quindi potete immaginare lo sconcerto nell’udire una notizia del genere.
Gruppi WhatsApp lampeggianti di messaggi increduli, la colonna di fumo fotografata dalla finestra di questo o quello studio, un groppo in gola e infine la decisione di andare a vedere di persona cosa stesse succedendo.
A Hôtel de Ville molte persone stanno in piedi sulla grande fontana – alcuni curiosi, altri un po’ più nichilisti (come il tipo che, sogghignante, mi chiede un accendino – in francese feu, letteralmente “fuoco”), la maggior parte sinceramente costernati per quell’immagine tanto improbabile quanto reale.
C’è chi piange, chi prega, chi scatta fotografie.
Ho l’impressione che ognuno di noi si trovi in quel luogo in modo simile allo stare al capezzale di una persona malata: aspettiamo, speriamo nel meglio e se Notre-Dame deve cadere vogliamo essere lì per darle il nostro ultimo addio.
Notre-Dame, alla fine, non è crollata. La struttura non ha ceduto.
Ma il suo animo antico ha veramente resistito ai cortocircuiti contemporanei?
Ho bisogno di scomodare, in questa sede, Walter Benjamin e il complesso concetto di aura.
Per Benjamin, in generale, l’aura è qualcosa che le opere d’arte irraggiano e che ha a che fare con hic et nunc, lontananza nella vicinanza e sacralità.
Per farla semplice (e mi perdonino qui gli esperti): ci troviamo davanti a Notre-Dame, nell’Ile de la Cité, davanti a un’opera unica e irripetibile.
Questo monumento ci rimanda a una distanza, all’eternità che un simile prodotto dell’arte porta su di sé, alla sua origine sacrale, culturale.
Quest’opera ha, insomma, un’aura – concetto peraltro applicato da Benjamin anche alla natura:
«Seguire, in un pomeriggio d’estate, una catena di monti all’orizzonte oppure un ramo che getta la sua ombra sopra colui che si riposa – ciò significa respirare l’aura di quelle montagne, di quel ramo». (1)
Cos’è successo, però, nel Novecento – e in realtà già prima, con la fotografia?
L’arte, progressivamente e in concomitanza con lo sviluppo del capitalismo, ha perso la sua aura.
Ha smesso di essere unica, irripetibile e si è fatta riproducibile: è diventata prodotto di consumo di massa, ha modificato le sue tecniche, i suoi canali di distribuzione, il suo rapporto con l’eterno.
Nel caso specifico di Notre-Dame: molti di noi non l’hanno mai vista, non hanno mai assistito al fatto nudo e crudo della sua presenza.
Notre-Dame è film-Disney, è pubblicità.
E anche chi ha avuto la fortuna di visitarla ne fruisce come prodotto di consumo: biglietto-di-ingresso, coda-alla-cassa, selfie-su-Instagram.
Eppure tutti la piangiamo.
Piangere Notre-Dame ha in sé qualcosa di incoerente?
Piangiamo un monumento eterno senza rendere veramente conto della distanza, lontananza, originalità che porta con sé? Oppure, oggi, Notre-Dame rappresenta qualcosa di diverso ma altrettanto profondo?
In Rumore Bianco, Don De Lillo descrive un episodio del tutto singolare, di cui riporto alcuni frammenti:
“Presto cominciarono ad apparire i cartelli stradali. LA STALLA PIÙ FOTOGRAFATA D’AMERICA. […] Tutti erano muniti di macchina fotografica, alcuni persino di treppiede, teleobiettivi, filtri. Un uomo in un’edicola vendeva cartoline e diapositive, fotografie della strada prese da quello stesso sopralzo. Ci mettemmo in piedi accanto a una macchia di alberi a osservare i fotografi. Murray mantenne un silenzio prolungato, scribacchiando di quando in quando qualche appunto in un quadernetto. “La stalla non la vede nessuno” disse finalmente. […] “Noi non siamo qui per cogliere un’immagine, ma per perpetuarla. Ogni foto rinforza l’aura. Lo capisci, Jack? Un’accumulazione di energie ignote. […] Trovarsi qui è una sorta di resa spirituale. Vediamo solamente quello che vedono gli altri. Le migliaia di persone che sono state qui in passato, quelle che verranno in futuro. Abbiamo acconsentito a partecipare di una percezione collettiva. Ciò dà letteralmente colore alla nostra visione. Un’esperienza religiosa, in un certo senso, come ogni forma di turismo.” (2)
L’aura, forse, non è stata perduta, ma ha mutato la sua forma. Siamo connessi all’eternità, ma in altro modo.
Esorcizziamo il tempo che passa perpetuando una serie di immagini simboliche: la nostra identità sta nelle immagini, non nell’effettività di ciò che rappresentano.
L’incendio ha minacciato un’immagine consolidata, profondamente radicata in ognuno di noi – e, infatti, che sospiro di sollievo abbiamo tirato nello scoprire che tutto si può ricostruire! L’immagine ricomposta, l’identità preservata.
Sarà per questo che un fatto che ha avuto relativamente poche implicazioni pratiche ci ha sconvolto così tanto, in maniera così sproporzionata rispetto a fatti che di implicazioni ne hanno e di molto più gravi?
L’incendio a Notre-Dame ha minacciato una parte essenziale del nostro essere uomini, società, storia – il che di per sé non è sbagliato: è solo un modo di sentire.
Se il sentire, dunque, deve passare per l’immagine per entrare a far parte delle nostre coscienze, come fare a restituire la dignità di immagine a chi, attualmente, non ce l’ha?
Il problema della rappresentazione resta cardinale nella società contemporanea:
legati a un’immagine, esistiamo; privi di immagine, no.
Notre-Dame, per fortuna, esiste ed è parte di noi.
- W. Benjamin, L’opera d’arte nell’Epoca della sua Riproducibilità Tecnica
- Don De Lillo, Rumore Bianco
-
Blanchard vs. Blanchard: un matricidio moderno
21 Luglio 2024 -
Terre dialoganti: donne e arte
18 Ottobre 2021 -
Alla mia patria ovunque essa sia
5 Marzo 2021
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy