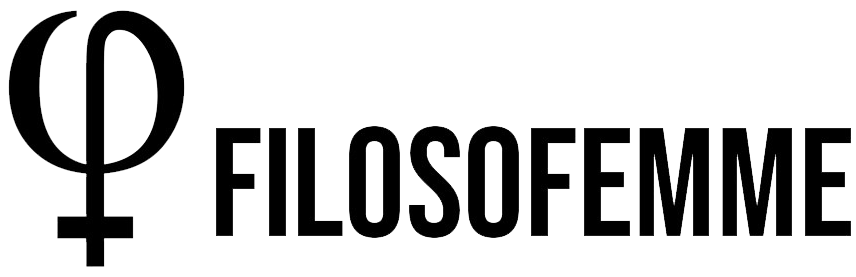Le più recenti classifiche musicali sono state dominate dall’indie. Il termine, contrazione di “independent”, indicava in un primo momento un approccio alla produzione musicale che, indipendente, si poneva come contraltare rispetto alle major discografiche. Successivamente, acquisendo dei caratteri specifici, alternativi alle sonorità mainstream, l’indie si è codificato come genere a sé stante.
Allo stato attuale delle cose, è uno strano ibrido: non è musica pop, anche se spesso ci assomiglia; non è di nicchia, perché appetibile per un pubblico molto vasto; non è poi tanto “independent”, viste le case discografiche che coinvolge. Trattare l’evoluzione dell’indie, in ogni caso, non è il mio intento. Che la sua natura sia cambiata, è evidente.
Tuttavia, per quali e quante possano essere le differenze tra l’indie di oggi e quello di ieri, ho l’impressione che ci offra una certa chiave di lettura della contemporaneità.
A livello preliminare, è bene circoscrivere il campo di indagine: parlando di indie farò riferimento al fenomeno italiano – le cui origini risalgono agli anni Novanta – Duemila, con Marlene Kuntz, Afterhours, Tre Allegri Ragazzi Morti, Baustelle, Le Luci della Centrale Elettrica, e che negli ultimi anni si è rinvigorito, spartiacque I Cani, ed è stato capace di imboccare la strada del mainstream, attraverso artisti attualmente sulla cresta dell’onda quali Calcutta, Gazzelle, Motta, Galeffi e tanti altri. Sempre a livello preliminare: chiedo scusa se, per spiegarmi meglio, racconterò dei fatti personali.
Giusto qualche giorno fa, ho sentito i miei genitori discutere con degli amici loro coetanei. Parlavano di figli, di università, di mondo del lavoro e — mi si scusi l’arroganza di ventenne — di come funzionano le cose non hanno capito proprio niente. È frustrante sapere che i tuoi genitori non hanno la minima idea del tipo di vita che conduci e degli ostacoli che si inframezzano tra il brillante futuro che ti è stato promesso e le tue possibilità nel presente.
Titoli di studio non più così rilevanti, stage non pagati che pretendono tra i requisiti del candidato un’esperienza nello stesso settore di almeno un anno, relazioni sociali che vanno e vengono perché — che senso ha impegnarsi con qualcuno, se non so neanche gestire me stesso? E poi, elefante nella stanza, il cambiamento climatico che, per quanto ci ostiniamo a negarlo, incombe come la nube di Nyodene D. di delilliana memoria sui nostri futuri possibili.
«Abbiamo tutta una vita davanti, sì davanti a un bar» . (1)
Ecco, mi sembra che l’indie parli proprio di questo: precarietà, ansia, escapismo.
E mi sembra ne parli, come genere-generazionale, a una fascia di utenti sempre più ampia: a questo imputo la sua virata verso il mainstream. L’indie dei primi Duemila parlava ai giovani adulti. L’indie di dieci anni dopo parla ad altri giovani adulti che, con qualche variazione sul tema, vivono le stesse difficoltà, a un grado di precarietà che si fa man mano sempre più intenso, più trasversale e più familiare a tutti.
Nota non tanto a margine: nello scrivere, mi rendo perfettamente conto che il mio punto di vista è quello del privilegio. Ho potuto frequentare l’università, mi sono lasciata la provincia alle spalle per vivere in una grande città e di fare uno stage non pagato posso permettermelo, visto che i miei genitori hanno le possibilità economiche per mantenermi. E non è una lamentela, ma una constatazione: la mia vita, nonostante il privilegio, è precaria.
Il punto è proprio questo: la generazione dei millennial, al di là dello stato di partenza, è in generale più povera della generazione che l’ha messa al mondo (2). Di chi è la colpa? Domanda irrilevante.
Ciò che importa è fare i conti con questo dato di fatto, accoglierlo e aggiustare di conseguenza l’etica del sogno che ci è stata tramandata.
«Io non avevo soldi, tu non avevi sogni. Meglio così» . (3)
Due elementi dell’indie, con le sue melodie strascicate che tanto spesso fanno da colonna sonora alle mie spese all’Esselunga («non ho lavato i piatti con lo Svelto e questa è la mia libertà» (4) mantra di vita), mi sembrano particolarmente interessanti: l’eco nostalgica per un passato non bene definito e i non luoghi. Questi ultimi sono stazioni, aeroporti, spazi per la fuga.
«Mi perderò altrove, a un passo dalla città, chissà dove. Mi perderò altrove, senza i messaggi e senza le mail». (5)
Il millennial vuole sfuggire a delle responsabilità che, verosimilmente, non lo porteranno da nessuna parte. Il presente fa paura, in primo luogo, perché è totalizzante: passa per i mezzi di comunicazione, è un presente costante che non permette pause. Bisogna rispondere ai messaggi, condensare la propria vita in poche righe di testo, essere reperibili in ogni momento — salvo poi dover incastrare un milione di calendari per trovare un giorno per vedersi di persona. In secondo luogo, questo presente assoluto conduce verso un futuro inerziale, non meglio definito.
«Vado di corsa e non so il perché, mi giro a guardare se perdo parti di me». (6)
Il futuro perduto ha la sua controparte nella nostalgia per un passato vissuto solo marginalmente.
Un po’ come quando, ai karaoke, parte Gli anni degli 883 e tutti cantano a squarciagola anche se quegli anni nessuno li ha vissuti, i testi delle canzoni indie sono ricolmi di memorabilia: il tetris, i vinili, le polaroid, i film cult. Feticci di un passato mai vissuto, ricercato come origine mitica di un presente inconsistente in cui si cercano stimoli («Ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare» (7) ) e il grande amore sembra l’unico abbandono possibile.
«Credo in una sola vita, che ti possa dare tutto anche senza la fatica, che possa farti stare bene senza domandare “Che ti ho incontrato a fare?”» (8)
Quella dei millennial è, più che una Ontologia, una Hauntologia — termine che rubo, forse in modo indebito, primariamente a Derrida. Decostruiamolo: la radice è “haunt”, infestare, il verbo del fantasma. Hauntologia è anche la pronuncia-fantasma di ontologia: l’essere e la presenza nascondono un’assenza, si parla di assenza nella presenza. Derrida lo conia, non a caso, in Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale (9); Mark Fisher, in Spettri della mia vita: scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti (10), lo applica alla cultura popolare del ventunesimo secolo. A proposito della musica scrive:
«La musica hauntologica riconosce implicitamente che le speranze create dalla musica elettronica post-bellica o dall’euforia della musica dance degli anni Novanta non esistono più: non soltanto il futuro non è mai arrivato, ma neppure sembra più possibile. Eppure quella musica rappresenta un rifiuto di rinunciare al desiderio di futuro. Tale rifiuto conferisce alla melanconia una dimensione politica, perché equivale alla rinuncia ad adattarsi agli orizzonti limitati del realismo capitalista.» (11)
Che questa definizione possa essere applicata all’indie italiano, è opinabile.
Certo è che il ritorno costante dell’ansia, dei farmaci (Paracetamolo di Calcutta, Lexotan de I Cani) e dell’alcool del venerdì sera dicono qualcosa sul trascinarsi a casaccio in un futuro incerto, attraverso un presente sfuggente, al quale ci si sottrae rifugiandosi in un passato mitico ma mai esperito, il cui correlativo oggettivo esemplare è la stampa di una fotografia digitale su finta polaroid.
«Più non son gli dèi fuggiti, e ancor non sono i venienti», scriveva Hölderlin. L’indie, a suo modo, traccia le linee guida di una fascia d’età non più adolescente, ma non ancora autorizzata dalle circostanze a sentirsi adulta — che fa di questa sua precarietà un essere-nella-forma-del-fantasma. E, come genere musicale, è tanto sincero quanto appetibile perché scanzonato, naïf: permette, attraverso la sua forma, di rendere catartica l’ansia generazionale, sublimandola in un liberatorio:
«Che schifo avere vent’anni, però quanto è bello avere paura». (12)
(1) Gazzelle, Tutta la Vita, in Punk, 2018.
(2) F. Rampini, Quei figli più poveri dei padri, gli anni Duemila come il Dopoguerra, Repubblica, 2016.
https://www.repubblica.it/economia/2016/08/13/news/rapporto_mckinsey_famiglie-145899035/
(3) Gazzelle, Meglio così, in Meglio così, 2017.
(4) Calcutta, Frosinone, in Mainstream, 2015.
(5) Eugenio in Via di Gioia, Altrove, in Natura Viva, 2019.
(6) Calcutta, Frosinone.
(7) Calcutta, Gaetano, in Mainstream, 2015.
(8) Canova, Vita sociale, in Avete ragione tutti, 2016.
(9) J. Derrida, Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, Cortina, 1996.
(10) M. Fisher, Spettri della mia vita: scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti, Minimum Fax, 2019.
(11) Ibi, p. 37.
(12) Coma Cose, Mancarsi, in Hype Aura, 2019.
Il fascino moderno dei vampiri
14 Luglio 2024Orobori spaziali
7 Luglio 2024Eric, una critica alla società
23 Giugno 2024
-
Il mito della bellezza: che cos’è e come liberarcene
10 Ottobre 2022 -
Sul concetto di destino
2 Dicembre 2020 -
Memestetica, il settembre eterno dell’arte
22 Ottobre 2021
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy