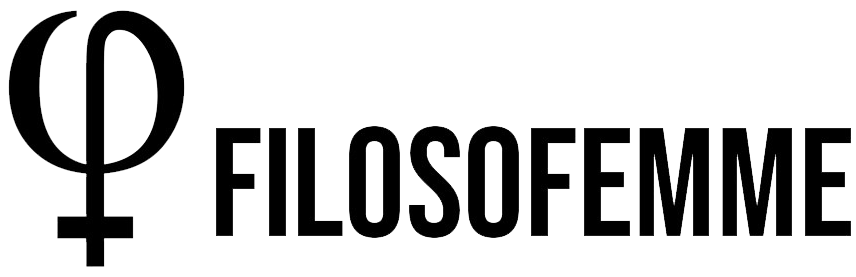Una delle parole che spesso sentiamo invocare è empatia; si parla di politiche dell’empatia, di movimenti empatici, di relazioni basate sull’empatia e ci si dimena cercando di dimostrare come una capacità animale, che già Charles Darwin – ma ancor prima David Hume – lodavano, possa esorcizzare le conflittualità esistenti nella nostra contemporaneità.
Dagli anni ’90, dopo il declino subìto nella prima metà del ’900, l’empatia torna alla ribalta grazie alle recenti scoperte dei neuroni specchio, divenendo una caratteristica di importanza fondamentale per la nostra specie, soprattutto all’interno delle dinamiche sociali e di cooperazione, in un’epoca attraversata dall’avvento del web, dalla globalizzazione e dall’individualismo.
Per quanto il termine rimanga spesso vago, anche nella letteratura scientifica, si è soliti identificarlo come la capacità umana (ma non solo) di “mettersi nei panni dell’altro”, una sorta di abilità nel decifrare le emozioni, le intenzioni e gli stati mentali altrui; ciò che però negli ultimi decenni è venuto a manifestarsi in modo più marcato è la visione – o sarebbe meglio dire speranza – di vedere nell’empatia il mezzo curativo e il collante ormai minato dall’individualismo, per risanare le nostre vite atomizzate.
L’empatia ha molti nomi: compassione, cura, proiezione, simpatia, contagio… la si ritiene un sentimento morale di partecipazione o identificazione con il vissuto dell’altro che permette a più soggetti di allinearsi entro uno stesso tono emotivo condiviso, e creare così le basi per azioni e pratiche di condivisione e solidarietà. In quest’ottica pare impossibile non pensare a questa abilità come un qualcosa di buono a priori, una sorta di garante per la giustizia sociale, un link per connetterci ai vissuti altrui.
Ma siamo davvero sicuri che questa nostra definizione ingenua del fenomeno dell’empatia possa esaurire ciò che essa è?
La sua etimologia deriva dal greco en-pathein, letteralmente “sentire dentro”, termine che nella cultura occidentale col tempo ha assunto vari e molteplici significati, divenendo una sorta di termine ombrello che racchiude in sé svariate capacità cognitive, coinvolgendo diverse aree neuronali ed emozioni individuali o collettive. Su che cosa sia l’empatia non c’è un consenso unanime, ma per praticità solitamente ci si riferisce a tutti quei processi causati dall’osservazione diretta di un’alterità, processi che ci permettono di comprendere lo stato psicofisico della stessa.
Sappiamo anche che questo fenomeno è sempre un processo situato: avviene cioè in uno spazio e in un tempo precisi, nella relazione tra un soggetto che manifesta un’emozione – più o meno consciamente – e un altro che la percepisce entro un orizzonte comune. L’incontro con l’altro, però, non si può ridurre alla superficiale attestazione della presenza del corpo altrui, né all’analisi delle sue espressioni. É di più, un oltre che è l’individuo stesso.
Nella relazione con un’alterità non ci troviamo dinanzi a semplici corpi spogliati di ogni prospettiva e connotazione, né a semplici emozioni extracorporee, prive di contesto; l’altro ci appare come un’unità di mente e corpo inscindibile che interrompe il nostro vivere.
Certo i movimenti corporei sono originariamente comunicazioni e scambi con il mondo esterno, ma soprattutto rivelano l’altro in tutta la sua complessità e inimitabilità, a scapito di tutte le risposte imitative immediate (vicarie) che biologicamente possiamo avere.
Vedere un volto triste può ben provocarmi una smorfia di tristezza, ma illumina anche la presenza di un individuo da me indipendente, che ha un vissuto diverso dal mio che, per quanto potrà sembrarmi famigliare, sarà sempre prospettico e quindi soggettivo, simile quanto distante dal mio vissuto. L’empatia richiede perciò attenzione, memoria, immaginazione e soprattutto apertura, l’andare oltre le risposte emotive immediate per avvicinarsi all’altro tenendo bene presente la distinzione tra me e colui/lei che mi sta davanti.
Le risposte empatiche variano, non esistono risposte “tutto o niente”, estremamente positive o totalmente negative: piuttosto ognuno di noi oscilla tra il polo dell’iperempatia (eccesso di empatia) e la mancanza di coscienza per le modalità in cui entra in relazione con gli altri.
Le situazioni di forte stress, l’uso di sostanze psicoattive e alcune patologie psicologiche sono alcuni dei fattori che determinano il variare delle nostre risposte, ma anche il contesto, le credenze personali, i pregiudizi, il rapporto che intratteniamo con il destinatario e il nostro stato d’animo contribuiscono a determinare il grado di empatia che saremo in grado di sostenere nella relazione con l’altro.
Nelle nostre vite utilizziamo spesso la metafora della connessione: siamo sempre e tutti connessi, ce lo ripete la scienza, l’universo è formato da connessioni di atomi, corpi, habitat, pianeti, galassie e così via; ce lo ricordano i nostri smartphone tra trilli e vibrazioni, e ce ne rendiamo conto ogni qualvolta proviamo ad incastrare i nostri mille impegni quotidiani. Ma può la connessione essere sufficiente per creare empatia?
La risposta è no; i processi globali (città, mercati, social network, finanza ecc.) vissuti nei modi più disparati a livello individuale e culturale devono essere riconosciuti nella loro natura di processi situati e prospettici, come modalità di vivere specifiche di individui e gruppi, perché è solo in questo contesto – quello dove il senso comune, la realtà globale, si incontra e scontra con le modalità di percezione a livello individuale o collettivo – che può darsi empatia.
Essa necessita di tempo, di apertura a diverse prospettive e vissuti, di comprensione e immaginazione, qualità ben distanti dalle regole del mondo attuale, in perpetuo movimento frenetico.
Richiede tempi e spazi che non siano di mera connessione ma di condivisione, di esperienza relazionale che possa mettere in risalto le contraddizioni tra l’esperienza personale e la sfera politico-sociale, lo scarto – sempre presente – tra la vita individuale e quella comune.
L’empatia così descritta non è un sentimento, un’emozione immediata alla vista dei patimenti altrui (la cosiddetta “empatia affettiva”); è piuttosto uno sforzo costante per aprirsi all’altro, un processo che richiede un coinvolgimento non solo emotivo ma più propriamente cognitivo (empatia cognitiva), che ci coinvolge e ci chiede di essere disponibili ad essere cambiati nella relazione con l’altro/a.
Proprio per la sua natura di esercizio e processo impegnativo spesso può fallire, può cioè non favorire l’associazione e la cooperazione e, in alcuni casi, estremizzare il senso di appartenenza al proprio gruppo d’origine a scapito di un’apertura verso coloro che sono riconosciuti come “diversi”, creando così quella modalità di relazione basata sull’opposizione amico/nemico che alimenta le conflittualità dei vari gruppi sociali.
Possiamo pensare l’empatia in chiave fenomenologica come un fenomeno concreto, un incontro sensibile tra più individui dove entrambi sono parti di una relazione – la relazione empatica – nella quale gli stati mentali altrui si colgono proprio e solo all’interno di queste manifestazioni psichiche e fisiche.
L’individuo è allora un mondo da scoprire tramite la percezione delle manifestazioni che il corpo dell’altro permette di cogliere, è il corpo –ancor prima del sentimento di condivisione – che mi permette, preriflessivamente, di cogliere l’altro come vivente con esperienze proprie. Perciò l’empatia non potrà essere uno stato mentale privato e individuale, ma piuttosto un fenomeno relazionale che dipende dalla presenza di due individui, entrambi i quali, lungi dall’essere passivi, sono attivi e partecipi al processo.
Comprendere l’altro non significherà rappresentarci internamente la sua emozione, né proiettare su di lui la nostra idea di tale patimento, ma piuttosto comprendere la sua prospettiva, la sua risposta a ciò che ha vissuto, con la possibilità di aprirsi a nuovi orizzonti di significato e di azioni anche per noi stessi.
In ultima istanza l’empatia è la possibilità stessa di vivere, laddove vivere per i corpi animati significa relazionarsi ed essere irriducibilmente proiettati verso l’esterno e quindi a rendersi manifesti entro le relazioni, lasciando che queste ci indirizzino verso nuovi scenari e chance di azione.
Bibliografia:
Laura Boella, Empatie. L’esperienza empatica nella società del conflitto, Raffaello Cortina Editore, 2018.
Laura Boella, Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, Raffaello Cortina Editore, 2018.
-
Vivere mille vite
23 Ottobre 2020 -
Antigone: una lettura femminista
13 Giugno 2022 -
Tragedia e filosofia. Una storia parallela
21 Agosto 2020
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy