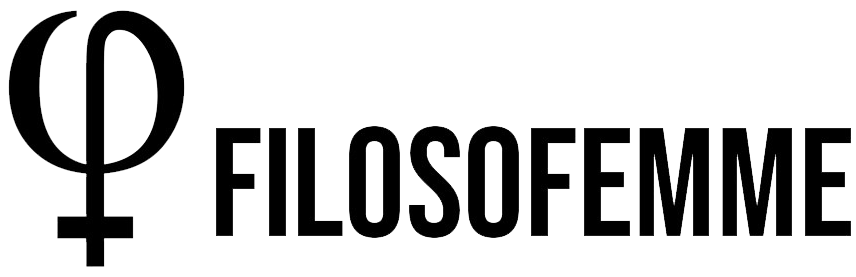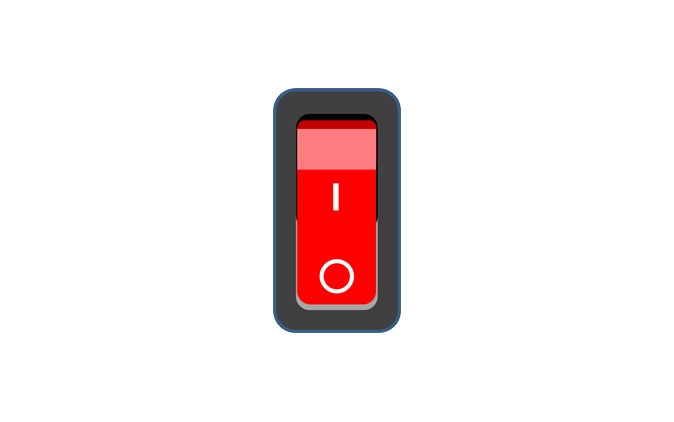
Durante la notte di Ognissanti, Tzia Bonaria Urrai entrava nella stanza di Nicola Bastìu.
Coperta da un velo nero, sapeva che avrebbe trovato la porta dischiusa: era la notte in cui gli usci di tutte le dimore restavano aperte, perché le anime dei defunti potessero rifocillarsi con il cibo lasciato dai loro discendenti.
Bonaria – l’accabadora – era però parte del mondo dei vivi e faceva visita a Nicola Bastìu per realizzare il suo più grande desiderio: morire (1).
Acabar, in spagnolo, significa “finire”. Sa Accabadora, in Sardegna, è colei che finisce.
Non è considerata un’assassina, ma un’ “ultima madre”: la prima è quella che ti mette al mondo; l’ultima è quella che ti permette di lasciarlo quando ormai non ti resta che sofferenza.
Eutanasia significa letteralmente “buona morte”.
Per i greci, una vita poteva essere considerata felice solo se si concludeva con una bella morte: non tanto facile o indolore, quanto piuttosto gloriosa. In questo modo, l’uomo perito di buona morte si sarebbe guadagnato l’immortalità attraverso il ricordo di sé.
Per i contemporanei, invece, la buona morte è incarnata da una dipartita priva di sofferenza, possibilmente in tempi non prolungati.
Quando queste condizioni non sussistono, si pone il problema dell’interruzione della vita.
È lecito che un uomo desideri morire?
O meglio, è lecito che – qualora un uomo desiderasse morire – egli possa vedere esaudita la propria volontà?
Non va essa oltre ciò che può essere di dominio dell’uomo? È la vita un bene di cui l’arbitrarietà umana può disporre?
Per procedere in questa riflessione, è necessario distinguere due tipologie di interruzione della vita: l’eutanasia e il suicidio assistito.
Il discrimine consiste, in breve, nell’autore del gesto: l’eutanasia è l’interruzione procurata da una persona diversa da quella che muore, là dove si presuppone che quest’ultima sia afflitta da condizioni di malattia sofferente e irreversibile; il suicidio assistito consiste nell’aiuto medico nei confronti di un soggetto che ha deciso di morire, ma senza che terzi intervengano nella somministrazione dei farmaci.
A sua volta, l’eutanasia viene talvolta suddivisa in due accezioni: attiva e passiva.
La differenza è sottile e utile per lo più alle fazioni che si scontrano nel dibattito etico per tirare acqua al proprio mulino.
Si definisce “eutanasia attiva” l’insieme delle pratiche utili a far morire un individuo (ad esempio: un’iniezione); si chiama “eutanasia passiva” ciò che lascia morire lo stesso individuo (ad esempio: l’omissione o la sospensione di una terapia utile al mantenimento in vita).
A ognuno di noi quindi la facoltà di prendere una posizione, evidenziare discrepanze semantiche dell’una o pratiche dell’altre e di responsabilità sottese o mancate.
È invece d’obbligo evidenziare che è bene prendere le distanze da un valore distorto: quello di selezione.
Lontano dal significato insito in eutanasia si trova chi associa la pratica alla volontà di terzi di eliminare gli “indesiderabili”, i soggetti volgarmente definiti come un “peso per la società”, conseguentemente legando a doppio filo il termine alla selezione nazista, riferendosi a quella che è stata chiamata anche eutaNAZIa (2).
L’eutanasia dipende dall’autodeterminazione del soggetto che chiede la propria morte tramite testamento biologico, non da un criterio arbitrario imposto dalla società perché essa possa essere epurata da chi non apporta a essa un utile sufficiente.
Possiamo allora tentare di fornire una risposta agli interrogativi posti sopra.
Come è prevedibile, non ha la pretesa di valere universalmente, perché si scontra senza possibilità di compromesso con il presupposto di coloro che ritengono la vita un dono di una volontà superiore, un bene intoccabile di cui l’uomo non può farsi padrone.
Dal punto di vista laico, invece, vita è un progetto la cui direzione dipende dal singolo che l’ha creato e tale progetto comprende anche il momento del fine vita.
Il postulato perché si possa parlare di volontà di interrompere la propria vita è quello di vita non ritenuta degna di essere vissuta: esprime questo giudizio unicamente il titolare della vita stessa.
Che cosa è lecito in Italia riguardo al tema di interruzione della vita?
Nel nostro Paese è entrata in vigore il 31 gennaio 2018 la legge riguardante il testamento biologico, ossia quel documento che un soggetto può stilare per definire le future richieste inerenti al termine della propria vita.
Essa prevede che il paziente possa rifiutare i trattamenti sanitari indicati per la patologia che lo affligge, là dove essi comprendono anche la nutrizione e l’idratazione artificiale: è quindi possibile per un individuo esimersi dalla somministrazione di ciò che è necessario a mantenerlo in vita, qualora sia in grado di comunicare autonomamente (se ciò non fosse possibile, è possibile indicare nel proprio biotestamento un fiduciario che agisca in caso di mancata capacità di intendere e di volere).
Non può invece richiedere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali (3).
In altri termini, lo Stato ha dimostrato di aver compiuto passi in avanti da non sottovalutare circa il fine vita.
Tuttavia, dal decreto si evince che è legittimo che un individuo chieda di essere lasciato morire, ma non che la sua dipartita venga agevolata attivamente tramite vera e propria eutanasia, né tramite suicidio assistito, metodi attraverso i quali potrebbe porre fine più celermente a un percorso di agonia.
I passi verso la fine del dibattito sono lenti e pesanti, ma potrebbero far riporre speranza nell’esistenza di una conclusione che metta in primo piano l’autodeterminazione dell’individuo.
Ma quanto sarà lungo il percorso?
- Cfr. M. Murgia, Accabadora, Giulio Einaudi editore, Torino, 2009.
- Cfr. J-Y. Goffi, Penser l’euthanasie, Presses Universitaires de France 2004. Trad it. A. Serafini, Pensare l’eutanasia, Giulio Einaudi editore, Torino, 2006.
- Per il testo completo cfr. www.gazzettaufficiale.it
Il saluto di rubriETICA: riflessioni conclusive
2 Dicembre 2019La disforia di genere tra mito e realtà
4 Novembre 2019Se la cicogna è in laboratorio
7 Ottobre 2019
-
Plasticene
3 Marzo 2023 -
Noi, animali
18 Aprile 2024 -
Roland Barthes: la fotografia che punge
4 Marzo 2020
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy