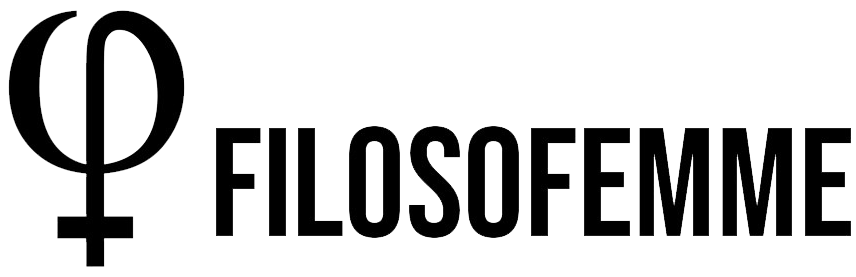Tutto ha inizio il 9 gennaio del 2020. Ci troviamo in un ospedale di Wuhan, in Cina, dove un uomo di 61 anni è stato la prima vittima nel mondo, ufficialmente deceduta, per colpa di un nuovo coronavirus.
Da quel momento nessun Paese è stato risparmiato dal diffondersi del SARS-CoV2, il virus responsabile dell’epidemia attuale. Ora ci stiamo avvicinando ad un bilancio globale di un milione di morti. E nonostante oggi si tenti di controllare meglio il contagio, grazie alle misure di igiene e di protezione personale, la COVID-19 (1) continua a uccidere migliaia di persone ogni settimana.
Da gennaio, incessantemente, riceviamo con sgomento le cifre spropositate dei decessi a causa del virus. La maggior parte di questi dati riguarda persone morte da sole negli ospedali o nelle RSA, senza il conforto dei propri cari.
Chi muore in isolamento non ha la possibilità di congedarsi dai propri affetti e di condividere con loro le ultime volontà, prigioniero di una condizione di abbandono affettivo. Per non parlare della solitudine della tumulazione, a cui abbiamo assistito, il rituale funebre completamente stravolto e soprattutto l’elaborazione del lutto, per molte famiglie quasi impossibile. I funerali vengono vietati, si chiudono le case funerarie e le sale di commiato. Muta, pertanto, l’antropologia della morte e del lutto in particolare, dal momento che le esequie rappresentano uno tra i momenti più importanti della sfera sociale, oltre che un’esperienza di distacco profondamente intima e personale.
Ogni civiltà, fin dalle origini, si è inevitabilmente scontrata con la morte e ha dovuto elaborarla quasi “civilizzandola”, con modalità confacenti alle esigenze della vita collettiva e secondo le proprie usanze istituzionali. Ciascuna società ci ha tramandato particolari pratiche di sepoltura e caratteristici rituali di accompagnamento.
Interessante è la periodizzazione della morte proposta da uno tra i maggiori storici francesi, Philippe Ariés, nel suo scritto Storia della morte in Occidente. L’autore descrive quattro fasi storiche ben definite.
La prima riguarda l’alto Medioevo, in cui la morte è “addomesticata”. Tipica dei cavalieri della chanson de geste. Non si muore senza preavviso, senza avere avuto il tempo di sapere che si sta per morire. «Sappiate, disse Galvano, che non vivrò altri due giorni» (2).
L’atteggiamento più diffuso di fronte alla morte è quello della rassegnazione. La morte viene accettata come un fatto biologico e spontaneo.
Con l’avvento del Cristianesimo la fine dei tempi si caratterizza in quanto timore del giudizio, che viene rappresentato come una vera e propria corte di giustizia: per morire sereni, bisogna aver vissuto in rettitudine.
A partire dal XVIII secolo, la cultura occidentale esalta e drammatizza la morte e si concentra sulla morte non propria ma dell’altro, dell’amato. Prende corpo il culto delle tombe e dei cimiteri.
«La morte era diventata un avvenimento più importante; occorreva dedicarle una cura particolare […]» (3).
L’ultima fase storica della concezione della morte, secondo Aries, è quella attuale, della morte proibita. Per la quale la morte scompare, i riti funebri perdono la loro carica emotiva. È fondamentale che gli amici e i parenti si accorgano il meno possibile che «la morte sia passata» (4) .
Il dolore deve essere privato e non troppo manifesto.
I cimiteri sono posti fuori dalle città e nella società nascono figure specializzate nell’organizzazione dei funerali. Prevale il culto della memoria, le commemorazioni devono confortare, quello che conta veramente è che dopo la morte gli altri si ricorderanno del nostro passaggio.
Si delinea una comunità che vuole evitare il trauma della morte. Lo stesso Edgar Morin, filosofo e sociologo francese, parla di “società amortale”, poiché se da un lato i progressi della ricerca consentono di migliorare e allungare la vita, dall’altro la morte è diventata un vero tabù. Così scrive Morin:
«Il problema è che, rinunciando alla riflessione, non si riesce a bandire sul serio il punto di approdo di ogni vita e così la morte, a cui si sbatte in faccia la porta, ritorna attraverso le finestre della nostra disattenzione […]» (5).
Si nega la morte come evento drammatico perché si adempie all’obbligo sociale di essere sempre e assolutamente felici, con la necessità di allontanare ogni causa di turbamento.
L’uomo ha sviluppato un’idea della vita secondo la quale il suo cessare non lo riguarda, si illude di essere immortale.
Ma con l’arrivo del virus abbiamo iniziato a sentire la morte vicina, reale e presente nelle nostre vite, è questo inevitabilmente ci ha sconvolto.
Al contrario, però, la certezza di morire potrebbe rivelarsi utile a farci pensare con più consapevolezza la vita stessa.
In questo senso il filosofo spagnolo Fernando Savater afferma – in Le domande della vita – proprio questa concezione, secondo la quale: «la certezza personale della morte ci umanizza, vale a dire ci trasforma in veri esseri umani, in mortali. Non a caso i Greci utilizzavano giustamente la stessa parola per dire “umano” e “mortale”» (6).
Allora, dagli antichi a oggi, osservando il variare dell’approccio alla morte e alla perdita sino a quello extra-ordinario della nostra contemporaneità, possiamo maturare la consapevolezza che essere mortali è un momento di crescita e di apprendimento e non solo una perdita di coscienza: morire è la condizione stessa dell’esistenza.
(1) https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/il-covid19-o-la-covid19/2787
(2) P. Ariès, Storia della morte in Occidente, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano, 1998, p.18.
(3) Ivi, p. 52.
(4) Ivi, p. 71.
(5) E. Morin, L’uomo e la morte, Erickson, Trento, 2014, p. 11.
(6) F. Savater, Le domande della vita, Laterza, Roma, 2006, p.4.
-
Roland Barthes: la fotografia che punge
4 Marzo 2020 -
Reset. Politica e videogiochi
8 Settembre 2023 -
La filosofia come ars vivendi
23 Aprile 2018
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy