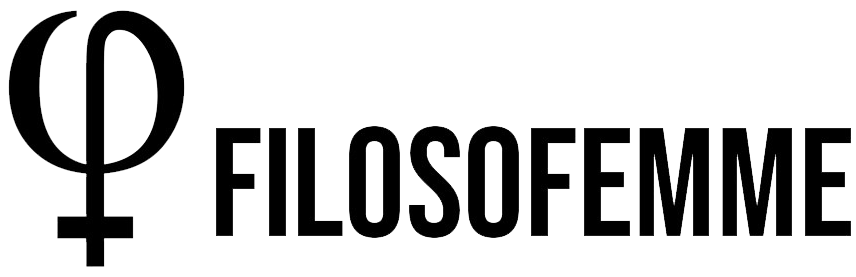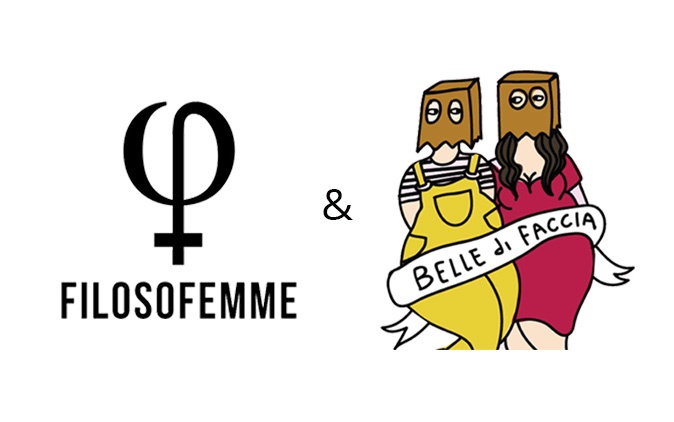Che l’amicizia sia uno dei legami centrali della vita di ognuno è ormai indiscusso. Quello che non tutti sanno, però, è che può essere non solo un profondo sentimento che nasce tra due individui che decidono di condividere parte della loro vita insieme, ma anche e soprattutto un forte valore politico.
Dell’amicizia come virtù politica ce ne parla Hannah Arendt, filosofa e teorica del Novecento, nel saggio L’umanità in tempi bui, quando afferma che solo l’amicizia può salvare l’umanità in periodi in cui «il mondo diventa inumano, inospitale per i bisogni umani» (1).
Sono proprio la distruzione e l’orrore in cui cade l’Europa nella prima metà del secolo scorso a suggerire ad Arendt che solo l’amicizia può risollevare le sorti del mondo.
Quando, cioè, il mondo ricade nell’oscurità e nell’angoscia, rendendo ogni uomo ostile all’altro, proprio allora è necessario praticare atti di disinteressata amicizia, insegnando agli uomini a prendersi cura del prossimo per poter ricominciare.
Per la pensatrice tedesca l’essere amici non consiste nel semplice e puro condividere un sentimento privato, un legame affettivo, ma è soprattutto la premessa necessaria per poter ricostruire.
Essere amici è essere solidali, è condividere con l’altro, con l’amico che ci è accanto, la sventura dell’essere al mondo. Ma è anche e soprattutto la manifestazione di una promessa reciproca che gli esseri umani si scambiano: quella di prendersi cura gli uni degli altri e di ripartire da zero.
L’amicizia, allora, è quel sentimento fraterno che nasce tra le persone quando si stringono insieme nello spazio pubblico, senza escludersi a vicenda, ma riconoscendosi come simili, come pari.
È la philia aristotelica, quel senso di unione e comunione dei cittadini della polis a essere richiamata: ricominciare è innanzitutto costruire un nuovo mondo in cui tutti possono prendervi parte, senza distinzioni e gerarchie, ma semplicemente come eguali.
«Dobbiamo, dobbiamo esseri amici» (2), ripete più volte Arendt. Perché l’amicizia è innanzitutto trovare qualcuno con cui parlare, con cui condividere la bellezza delle cose del mondo, così come il senso tragico dell’esistere.
E il dialogo, ci ricorda Arendt, è la più alta manifestazione dell’humanitas: ci ricorda che abbiamo trovato qualcuno con cui siamo disposti a dividere il mondo.
D’altronde: «Per quanto le cose di questo mondo ci colpiscano intensamente, per quanto profondamente esse possano emozionarci e stimolarci, esse non diventano umane per noi se non nel momento in cui possiamo discuterne con i nostri simili» (3).
Essere amici, allora, è aprirsi all’ascolto dell’altro, dell’amico, del compagno fraterno con cui potersi confidare. È non essere mai soli in questo grigio universo, ma è avere accanto sempre qualcuno disposto a darci una mano e a ricordarci che, infondo, nessuno merita di rimanere solo.
(1) H. Arendt, L’umanità in tempi bui, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, p. 47.
(2) Ivi, p. 73.
(3) Ivi, p. 71.
-
Ondate del femminismo: analisi di un’etichetta
11 Aprile 2022 -
Intervista a Belle di faccia
8 Maggio 2019 -
Simone Weil: una vita controcorrente
5 Ottobre 2020
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy