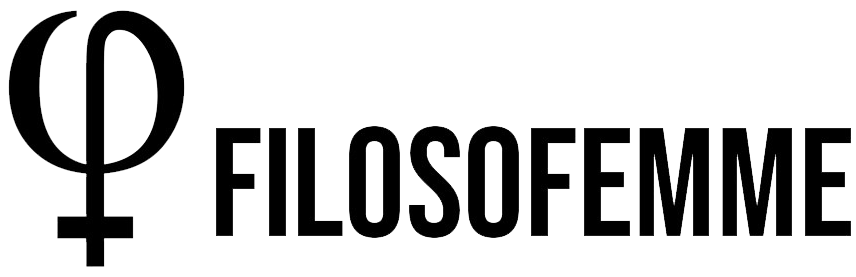«Quando qualcuno parla di PC, rimanda subito a un meccanismo di censura, agito da un’élite culturale vaga ma ben circoscritta, che ha per bersaglio quelli che sono considerati i capisaldi della cultura occidentale, compresa quella popolare, che sarebbero oggetto di una massiccia revisione moraleggiante» (1),
ci dice Jennifer Guerra nel suo contributo al volume Non si può più dire niente?. Si tratta per l’appunto di una raccolta di punti di vista, di varia provenienza e natura, in merito all’argomento del politicamente corretto – PC in breve. Sicuramente misurare la tenuta del concetto, in virtù della centralità dello stesso nel dibattito pubblico, risulta essere una mossa vincente, ma occorre forse mettere un po’ d’ordine.
Innanzitutto, mettiamo le cose in chiaro: la dittatura del politicamente corretto non esiste. Si tratta esclusivamente di un’espressione retorica volta ad evocare subito in chi la legge o la ascolta un atteggiamento ostile di chi, semplicemente, rivendica di essere rappresentato in un linguaggio che lo opprime, e che pur tuttavia è quello della sua quotidianità e delle sue relazioni.
Federico Faloppa spiega che modalità di discorso del genere «proprio attraverso la manipolazione» dello stesso, servono a far credere «che le questioni linguistiche e simboliche sarebbero irrisorie» (2). Ma come insegna la tradizione femminista, il simbolico è immediatamente politico, e il cambiamento nel linguaggio può «accompagnare, o anticipare […] almeno il cambiamento di percezione e sensibilità»(3) di certe individualità nei confronti di altre. Questo cambiamento di sensibilità è proprio quello che si riscontra nel pubblico della comicità, uno degli argomenti che immediatamente saltano alla mente quando si parla di PC, ed è infatti ampiamente trattato nel volume.
Insomma, sembra che il linguaggio inclusivo leda la possibilità di fare pienamente ridere. Questo pensiero è già l’ammissione di colpa di una comicità problematica, conservatrice.
La preoccupazione di moltə dellə autorə di alcuni dei saggi di Non si può più dire niente? è che il PC si trasformi in una pura formalità. Secondo Elisa Cuter, ad esempio, la wokeness (altro termine con cui si usa indicare il PC) «non è abbastanza radicale» (4) perché metterebbe al centro del discorso pubblico le questioni identitarie, oscurando quelle relative al conflitto di classe. Nell’ affermare questo, si dimentica che l’oppressione del capitalismo passa anche per il piano del simbolico e che razzismo o sessismo sono usati, e non creati, da esso.
Per altrə, invece, il PC è fin troppo divisivo. Addirittura, secondo Federica d’Alessio, chi rivendica una rappresentatività nel linguaggio sarebbe indisponibile «a offrire alla comunità in modo trasparente tanto le proprie idee quanto le basi scientifiche delle stesse» avendo l’effetto di trasportare «ogni elemento di realtà sul piano della relatività costruttivista» (5). In risposta a ciò, è bene chiarire che una persona, solo in quanto marginalizzata, non è automaticamente costretta a fornire spiegazioni costanti a chi, in realtà, non vuole ascoltare.
La stessa d’Alessio ammette (6) che quando con buona ragione le è stato chiesto di assumere per sé l’etichetta di cisgender, ella non l’ha fatto, segno del fatto che non sempre – anzi quasi mai – la comunicazione va a buon fine in mancanza di un ascolto. Serve poi comprendere che, se intendiamo la realtà come un costante divenire, quella della rappresentazione nel linguaggio non è una questione di relativismo, ma di approssimazione. Non ha la capacità di fissare per sempre le cose, possiamo tentare di renderlo il più adatto possibile agli effetti che vogliamo avere, renderlo giusto. E se, come dice Daniele Relli, il PC è «a fine […] del sogno illuminista» (7) ben venga. L’idea di un’universalità neutra oscura e opprime la Differenza, e conseguentemente la possibilità di coltivarla proficuamente.
Vera Gheno, nel suo contributo al volume, spiega che parlare di linguaggio inclusivo non significa discutere solo di etichette, ma di ingiustizia discorsiva, la quale «ha un ruolo per nulla secondario, proprio per il ruolo “agente” e “nominante” delle parole» (8).
Infatti «spesso, chi non è “conforme” non ha modo di farsi ascoltare o, ancora prima, di farsi sentire: i suoi spazi di parola sono ristretti, risicati» (9). Sono d’accordo con lei quando afferma che resistendo al cambiamento linguistico, il risultato è quello di trovarci davanti a una lingua divisa tra «chi parla e chi al massimo può essere parlato» (10). Proprio per questo motivo, consiglio di leggere Non si può più dire niente a chiunque voglia avere una prospettiva il più ampia possibile sul tema del politicamente corretto e dei meccanismi ad esso legati, ma invito chiunque a non dimenticare le ragioni per cui rivendicare un linguaggio più inclusivo è un’urgenza, e non un vezzo, di moltə.
Grazie a UTET!
(1) M. Bordone, E. Cuter, [et al.], Non si può più dire niente? 14 punti di vista sul politicamente corretto, UTET, Milano 2022, p.126.
(2) Ivi, p. 88.
(3) Ivi, p. 86.
(4) Ivi, p. 35
(5) Ivi, p. 55.
(6) Ivi, p. 51.
(7) Ivi, p. 154.
(8) Ivi, p. 112.
(9) Ibidem
(10) Ivi, p. 124.
Un’altra cena rovinata
25 Luglio 2024Il pozzo della solitudine
19 Luglio 2024Prendersi cura
12 Luglio 2024
-
La rivincita del famegaze
17 Aprile 2023 -
Il femminile nelle tragedie greche
30 Maggio 2022 -
Dr. House: un medico-filosofo
13 Gennaio 2021
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy