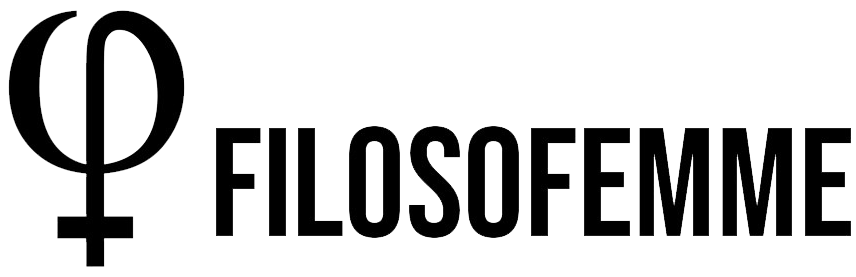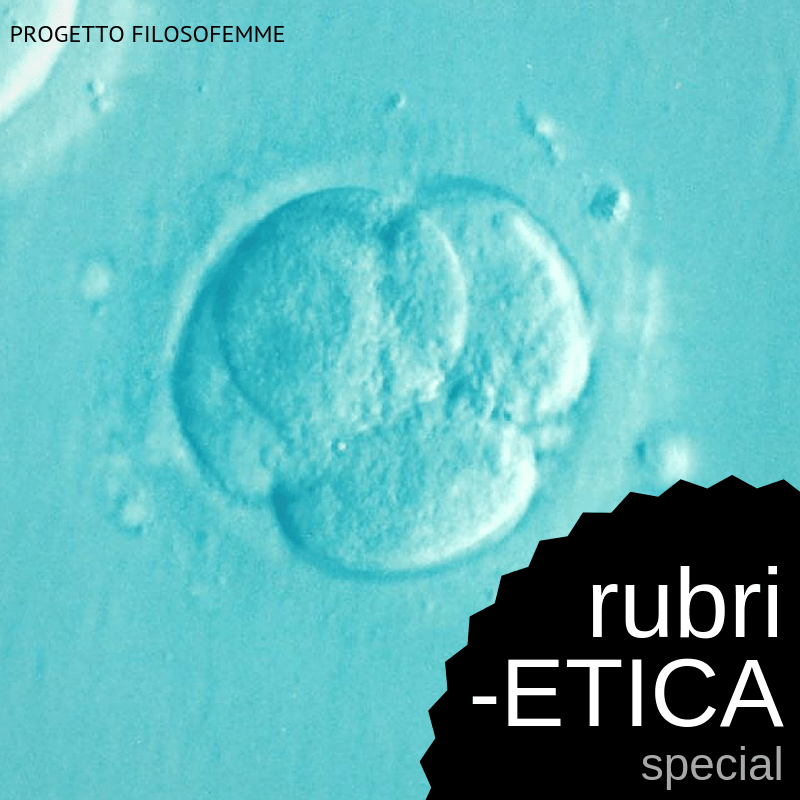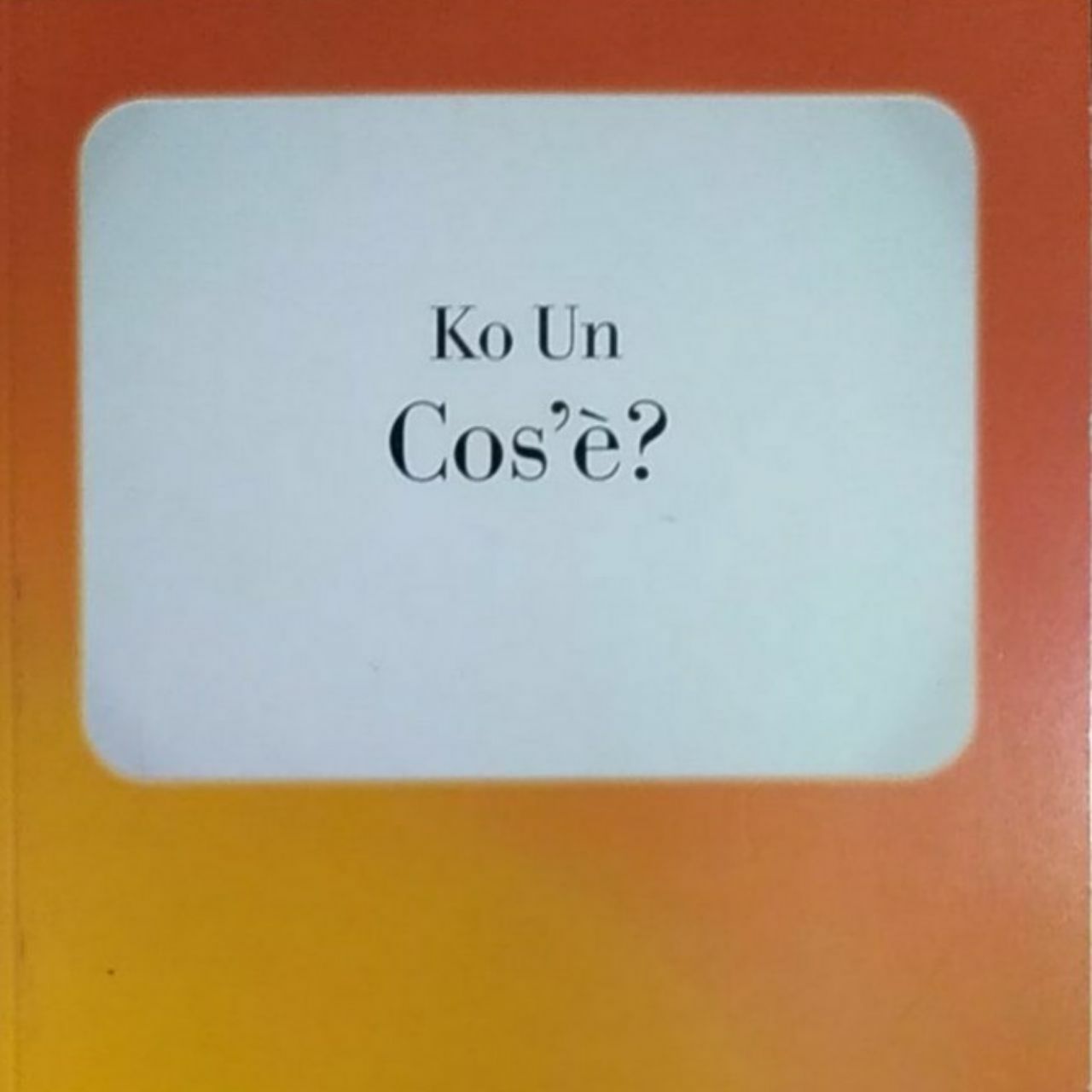Da circa tre anni lavoro alla LILT di Roma (Lega italiana per la lotta contro i tumori), nello specifico mi occupo di aiutare le persone a smettere di fumare, così propongo loro un percorso filosofico centrato sul riconoscimento dei propri bisogni e sulle responsabilità che ci assumiamo compiendo delle scelte. Oltre a vivere le gioie e le difficoltà che lo stare in relazione con gli altri comporta, il corso antifumo ci consente di dialogare intorno a una tematica fondamentale per realtà come la LILT, il cui scopo principale è quello di sensibilizzare le persone alla prevenzione e alla cura di sé: è più importante il come o il quanto?
Durante il primo incontro, solitamente, regalo ai miei ospiti alcune parole significative che ritengo utili non solo per le nove settimane di attività previste dal corso, ma per il resto della loro vita. Sostiamo su parole che la Filosofia ha da sempre avuto molto a cuore: autenticità, responsabilità–libertà in quanto scelta (possibilità), volontà, automatismo (assenza di pensiero). Dopodiché racconto loro di un tale Martin Heidegger, che nel bel mezzo del Novecento descrisse gli uomini come esseri gettati nel mondo, come esseri per la morte. Ritrovarsi a vivere non è frutto di una nostra scelta, non scegliamo il nome con il quale verremo identificati e, soprattutto, come ci siamo ritrovati in questo corpo; così, ad un certo punto (che non ci è dato sapere – altra fregatura!) esso non avrà più vita.
Le reazioni sono ovviamente disparate, molti sorrisi amari, il più delle volte si ammette di non riflettere mai su tale aspetto.
Non siamo abituati a pensare che, per ora, ci è concessa una vita e che non sappiamo quando finirà. Ecco che, a questo punto, entra in gioco il concetto di sommo bene aristotelico: la felicità. Li invito a non focalizzarsi esclusivamente sul lato tragico di tale condizione, piuttosto a cogliere la palla al balzo, indossando i panni dei veri filosofi. Più che darci risposte, cerchiamo di formulare delle domande in grado di stimolare ricerca e indagine interiore: “sto davvero facendo del mio meglio per essere felice?”
Essere consapevoli di poter “non essere più” (quindi essere-per-la-morte) può spingerci a concentrare la nostra attenzione sul “poter essere”?
La possibilità, la progettualità, quello spazio-tempo al quale la Filosofia può restituire estrema vitalità. Il Tempo, in fondo, è l’unica “materia della quale realmente disponiamo” (1). Per tale motivo esorto i fumatori ad assumere, come bussole d’orientamento, domande del tipo: “sto realmente impiegando il mio tempo per fare ciò che mi rende felice? Che senso do al tempo della mia vita? Lo impiego per fare cose che davvero mi interessano? Intrattengo relazioni che mi soddisfano realmente?”.
Insomma, durante questi nove incontri proviamo a capire come e cosa fare per provare ad essere felici, per esserlo a nostro modo, con i nostri corpi, caratteri, esigenze e aspirazioni.
«Il Tempo è la vita dell’anima», scrisse Plotino. Dunque noi siamo Tempo. Il Tempo è scandito dalle nostre scelte, quello che mangiamo, le persone che frequentiamo, il lavoro che scegliamo (o no) di fare. Tutto ciò contribuisce a definire lo stato di vitalità della nostra anima.
Com’è possibile avere paura della morte se viviamo il Tempo “a nostra immagine e somiglianza”?
Se il Tempo viene consumato, attimo dopo attimo, imparando ad assecondare passioni e concedendosi benevolmente di “stare nel dolore”, perché dovremmo temere la morte? Cosa sarebbe la morte di fronte a una vita vissuta a pieno? Rispondere sinceramente a tutte queste domande non è un compito facile. Rispondere in modo autentico alla richiesta di quotidiana felicità significa, appunto, smettere di raccontarsi bugie, scuse, storie e consigli altrui.
La Filosofia diviene azione virtuosa quando ognuno di noi comincia ad agire in sintonia, armonia (quella che gli psicologi chiamano “congruenza”) con i propri bisogni, creando così lo spazio ulteriore per l’accoglienza dell’altro (bene collettivo e condiviso). Sacrificare costantemente la propria felicità, sostituendola con il soddisfacimento dei bisogni altrui, è un costo troppo alto che il corpo spesso è costretto a pagare. Guai ad affannarsi nel “diventare ciò che gli altri vorrebbero noi fossimo” piuttosto che divenire se stessi.
Come capire se siamo, o no, sulla strada giusta?
Ascoltando il corpo e i segnali che ci manda: tensione mascellare, contrazioni, apnee, infiammazioni, nausea eccetera. C’è stato un tempo in cui, inconsapevolmente, smisi di respirare con il diaframma e il corpo immobile mi rivelava un particolare tipo di morte: quella dei desideri, dei bisogni autentici, dell’accettazione di sé, la morte del mio Tempo. Lavorare con le pratiche filosofiche mi ha permesso di ritrovare il respiro e il Tempo ha assunto di nuovo senso. La Filosofia insegna a sostare, raccogliersi, prendersi una pausa (attiva, costruttiva) volta a fare ordine mentale, quelle che Cartesio chiamava “idee chiare e distinte” (2), disegnare nuovi paesaggi di benessere, da noi scelti in maniera accurata.
Judith Shklar, filosofa lettone, nella sua opera Ingiustizia o cattiva sorte mostra abilmente il tallone di Achille degli esseri umani: siamo in costante turbamento per l’idea che il mondo in cui viviamo non sia del tutto determinato. Siamo terrorizzati dal caso, sostiene Shklar (3), dalla morte, aggiungerei. L’impossibilità di prevedere il corso degli eventi per evitare il verificarsi di circostanze negative si riduce così alla necessità di individuare sempre un responsabile delle nostre disgrazie, un colpevole adeguato.
Tale impossibilità di previsione ci induce a suddividere il tempo in maniera geometrica, affidandoci compiti costanti ai quali dover assolutamente provvedere (ne andrebbe della nostra autostima!). Ci rinchiudiamo in schemi da dover seguire fino allo sfinimento del corpo, che, ahi lui, si consuma ed esaurisce. Confidiamo in tali schemi come fossero la giusta medicina per la malattia “ignoto”. Per dirla alla Leibniz, non riusciamo ad accettare l’idea che il mondo in cui viviamo non sia il migliore dei mondi possibili (4) (e quindi che anche ciò che accade di negativo abbia una sua ragion d’essere nell’economia generale della Creazione).
Henri Bergson, nell’opera Materia e memoria (5), ha meravigliosamente descritto la distinzione tra il tempo della scienza e il tempo del vissuto.
Il tempo della scienza è quello geometrico, oggettivo, quantitativo, in cui ogni momento è sempre uguale a tutti gli altri, un tempo misurabile che il filosofo francese associa all’immagine di una collana di perle, tutte uguali e distinte fra loro. Il tempo della vita, invece, è quello vissuto dai singoli individui ed è essenzialmente qualitativo: pensiamo a quanto non passi mai il tempo quando ci annoiamo e a quanto scorra velocemente quando stiamo facendo ciò che ci piace.
Ci sono degli attimi che possono dar senso a un’intera esistenza, il primo sguardo tra due innamorati, l’attimo della nascita, l’atto creativo di un artista eccetera. Il tempo vissuto è dunque impregnato di significati particolari per ogni soggetto e mai separabile dalla memoria del passato e dall’anticipazione del futuro. Bergson sostiene che, per il singolo individuo, il tempo del vissuto è sempre una durata: un intervallo temporale concreto e psicologicamente variabile, in cui si svolgono gli eventi della vita.
Rimanere fedeli al proprio vissuto, alla propria finitezza è ciò che suggerisce Nietzsche (6) rivolgendo un’aspra critica al Cristianesimo.
Esso ha cancellato il tragico dal proprio orizzonte di senso, sostituendolo con il concetto di redenzione che strumentalizza la sofferenza in quanto mezzo per riconciliarsi con Dio. A differenza del Cristianesimo, sostiene il filosofo tedesco, il Paganesimo sa invece essere tragico grazie alla sua fedeltà al finito.
Essere fedeli al finito non significa forse essere fedeli alla morte?
Non significa accettare la nostra condizione di insovvertibile finitezza? Secondo il filosofo di Röcken, solo rimanendo fedeli al finito siamo in grado di sopportare le contraddizioni, di sostenere le opposizioni, dunque in relazione proficua con l’aspetto tragico della nostra esistenza. Pensiamo anche al Nietzsche del Crepuscolo degli idoli. Ovvero come si filosofa con il martello e alla celebre frase: «ciò che non mi uccide mi rende più forte».
Parlare della morte, non per esorcizzarla, ma per considerarla parte integrante della vita, l’altra faccia della medaglia che ci ostiniamo a non voler guardare, ci serve per ricordarci che ora disponiamo di una vita da poter vivere e che per quanto ci sembra di non poter mai scegliere, certamente una scelta possiamo sempre concedercela: ascoltarsi e cominciare a diventare stelle danzanti!
«Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto i panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno di parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro».
Niccolò Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori, 10 dicembre 1513.
(1) L. Mortari, Avere cura di sé, Cortina Raffaello, Milano, 2019, p. 10.
(2) R. Descartes, Discorso sul metodo, Laterza, Bari, 2003.
(3) J. N. Shklar, I volti dell’ingiustizia. Iniquità o cattiva sorte?, Feltrinelli, Roma, 2000.
(4) G. Piluso, Il problema del male in Leibniz, Nuova Santelli Edizione, 2017, p. 16
(5) H. Bergson, Materia e memoria, Laterza, Bari, 2009.
(6) F. Nietzsche, L’ anticristo. Maledizione del Cristianesimo, Adelphi, Milano, 2004.
Orobori spaziali
7 Luglio 2024Elden Ring: this tarnished is on fire
9 Giugno 2024Abel, il pistolero di Baricco che legge Hume
21 Aprile 2024
-
Un libro forgiato all’inferno
16 Agosto 2018 -
Lo status morale dell’embrione
1 Ottobre 2018 -
Cos’è?
22 Ottobre 2018
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy