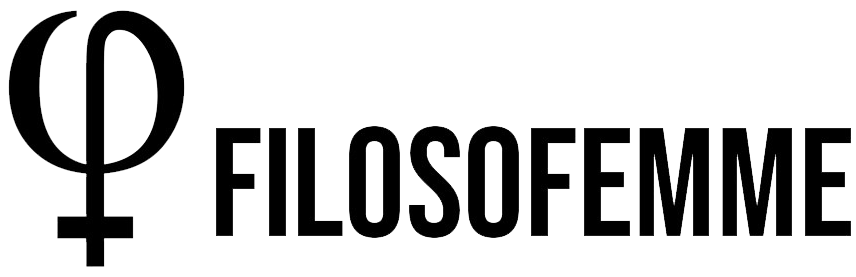Fake it till you make it.
Sii imprenditorə di te stessə.
Se vuoi, puoi.
Questi sono sicuramente alcuni dei mantra più diffusi nella contemporaneità, e non casualmente condensano tutti la medesima idea: oggi l’atteggiamento vincente, l’unico che può assicurare il raggiungimento della soddisfazione personale, è quello imprenditoriale.
Per imprenditorialità non si intende infatti l’attività pratica dell’imprenditoria, ma l’insieme di valori che nel discorso egemone governano quel mondo, come l’innovatività, la fame di successo, la lucidità di gestione dei problemi.
Tuttavia, se appare ben chiaro come queste idee possano applicarsi a coloro che propriamente sono imprenditorə, cioè a coloro che si occupano di un qualsiasi tipo di attività, investendo in essa il proprio denaro al fine di trarne profitto, non è altrettanto immediato il perché questo atteggiamento dovrebbe essere adottato da chiunque, nella vita di tutti i giorni.
Essere imprenditorə di se stessə significherebbe infatti comportarsi nella gestione di sé come ci si comporterebbe nella gestione, ad esempio, di un’azienda, quindi con disciplina e rigidità, “investendo” in sé, ossia vedendo ogni piccolo passo della propria vita un piccolo passo in più verso il guadagno che ci si sta costruendo.
Ma se usciamo da quella che Marcuse definisce come la chiusura dell’universo del discorso (1), che equivale all’identificazione di ogni parola con un concetto al fine di osteggiare il pensiero critico, possiamo scavare nella narrativa dell’imprenditorialità per scorgere tutti i suoi aspetti negativi che vengono mistificati nell’appiattimento del linguaggio.
Solo così possiamo scoprire che il guadagno a cui si punta probabilmente non arriverà mai, neanche se si seguono tutti i passi “giusti”, che la rigidità richiesta da questa narrativa corrisponde a un auto-disciplinamento di sé a cui mai si dovrebbe aspirare, perché tossico e dannoso proprio per la persona che lo perpetra.
Infatti, disciplinarsi significa seguire delle determinate regole e compiere delle determinate azioni che, in questo caso, risultano essere utili o all’accrescimento di sé o a quello del proprio profitto, ergo sono azioni produttive.
Quello che dovrebbe però saltare subito all’attenzione è che non sono i singoli individui a scegliere quali siano queste giuste norme da rispettare o queste giuste attività da compiere, ma che anzi esse sono identificate a livello sociale, e quindi sono in linea con quello che è il sistema egemone.
Attualmente esso è il sistema capitalistico, che si regge su una logica di mercato, quindi ha sicuramente un interesse al fatto che questa logica sia ubiquitaria, perché in questo modo sarà più difficile che venga contestata.
Allora uno dei motivi per cui la narrativa dell’imprenditorialità è tanto pervasiva è che essa è attivamente propagandata dal sistema, che ne trae un grosso vantaggio. Tuttavia, è necessario poi capire come questa riesca ad attecchire così tanto, come è possibile che sia tanto accettata da essere addirittura rispettata inconsapevolmente da tutti nella quotidianità.
Come spiega bene Silvio Lorusso nel suo libro Entreprecariat ciò potrebbe essere dovuto alle precarie condizioni lavorative che caratterizzano la nostra epoca; in tal senso «[…] per chi non trova lavoro o soddisfazione in esso, la risposta è diventare imprenditori in senso lato, ovvero gestire in apparente autonomia la propria identità professionale, che non si distingue poi tanto dall’identità in toto» (2).
Sarebbe dunque la mancanza di un impiego a spingerci a adottare un atteggiamento imprenditoriale, l’unico appiglio a cui aggrapparsi in un mondo dove tutto è flessibile e insicuro.
La paradossalità di questa soluzione sta nel fatto che autodisciplinandosi in questo modo, si fa proprio il gioco della logica di mercato, ossia proprio quella che in primo luogo non permette di essere tranquillə, professionalmente o non.
Forse la conseguenza peggiore della narrativa dell’imprenditorialità risiede nell’individualismo a cui essa costringe.
Infatti, la socialità è attivamente sfavorita in un mondo in cui ognuno “gioca per sé”, e di conseguenza in competizione con lə altrə, dato che tuttə iniziano dagli stessi blocchi di partenza e hanno quindi le stesse possibilità, basta essere lə migliorə.
Ma il gioco è truccato sin dall’inizio: non è vero che chiunque può raggiungere ciò che desidera solo con la propria forza di volontà e il proprio impegno, perché non è assolutamente vero che tuttə partono dalle stesse condizioni.
In sostanza, la retorica del pensare per sé ha come risultato principale quello di rendere ognuno individualmente responsabile di quanto gli accade, al fine di far scomparire dal discorso comune ogni attribuzione di colpa al sistema vigente, che in tal modo viene sempre meno criticato.
Risulta così chiaro che “essere imprenditorə di se stessə” non significa propriamente nulla, se non assumere atteggiamenti nei propri confronti che non solo non possono dare quanto sperato, ma non possono aiutare neanche nel tragitto che dovrebbe portare al traguardo.
Piuttosto che pensare a ciò che meritiamo perché abbiamo pedissequamente seguito le regole che ci hanno dato – sii sempre ottimistə e sempre produttivə, non dedicare il tuo tempo a attività inutili, pensa solo al lavoro – dovremmo cominciare a decostruire questa narrativa e pensare maggiormente alla dimensione sociale, in quanto solo un cambiamento di prospettiva collettiva in cui finalmente si riconoscano queste problematiche potrebbe portare a uno spostamento di valori, che liberi gli individui dalle colpe che non hanno.
(1) H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1968, pp. 102-138.
(2) S. Lorusso, Entreprecariat, Krisis Publishing, Brescia, 2018, p. 67.
Bibliografia
S. Lorusso, Entreprecariat, Krisis Publishing. Brescia, 2018.
M. Boarelli, Contro l’ideologia del merito, Laterza, Bari, 2019.M. Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista, DeriveApprodi, Roma, 2011.
-
TikTok e l’arte di imitare
24 Agosto 2020 -
La filosofia e la crisi dello Stato
27 Settembre 2021 -
Sesso e temperamento
13 Maggio 2022
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy