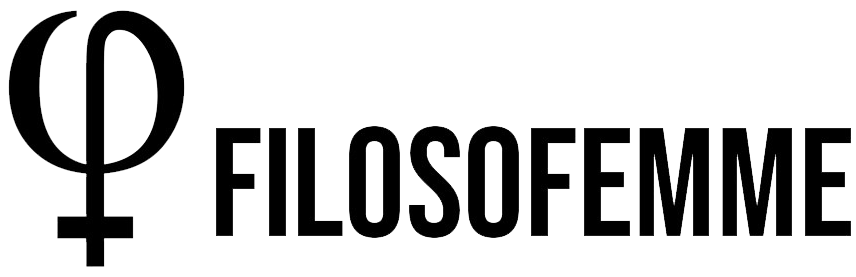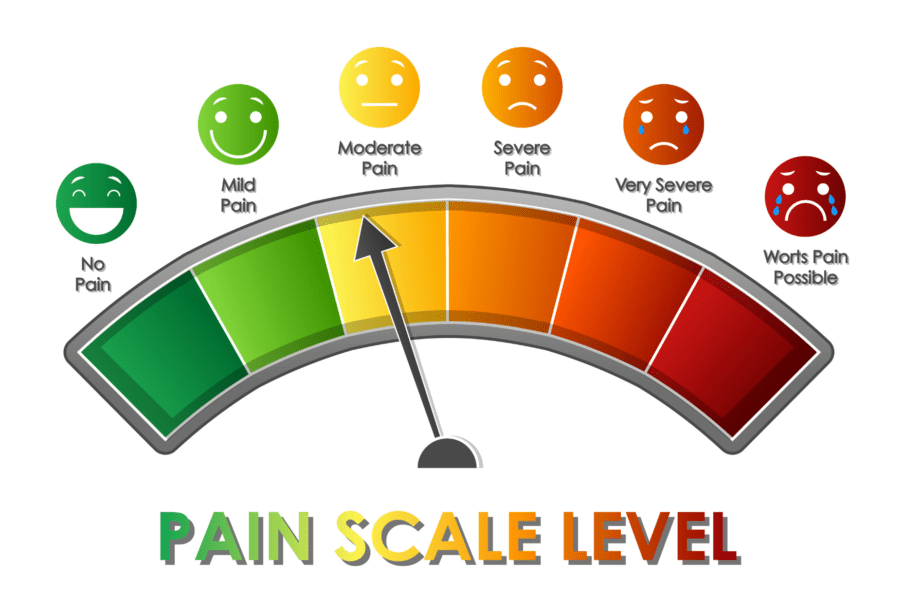
«Dimmi il tuo rapporto con il dolore e ti dirò chi sei» (1): è con queste parole di Ernst Jünger che il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han apre il suo libro La società senza dolore, svelando così fin da subito il tema affrontato nel suo saggio.
L’epoca attuale è caratterizzata secondo Han da una radicale algofobia (2), un atteggiamento di timore ed evitamento verso qualsiasi esperienza potenzialmente dolorosa.
La conseguenza di questa paura provoca nelle persone un’anestesia permanente, in cui si sfugge a ogni tipo di dolore, pene d’amore incluse, il cui esito consiste nella creazione di una «società palliativa» (3), che non affronta il malessere bensì lo allontana.
Il dolore viene interpretato come segno di debolezza, come qualcosa da eliminare o sconfiggere il più presto possibile in quanto non compatibile con gli elevati standard di prestazione richiesti dalla società: la passività insita nella sofferenza non merita un posto nella società attiva dominata dal “poter fare”, in cui il dolore viene privato di qualsiasi possibilità di espressione e condannato a tacere, dimenticando la sua grande funzione purificativa e catartica nel processo di guarigione di ciascuna persona.
Il dolore è considerato ormai senza senso, un supplizio corporeo, un male insensato da affrontare armati di analgesici.
Si può individuare chiaramente questo processo di farmacologizzazione a cui ci sottomettiamo in modo volontario per evitare sofferenze fisiche, psichiche, sociali proprio grazie all’uso di termini quali “analgesico”, “anestesia”, “palliativo”, che circolano in modo ripetitivo e ricorrente nel linguaggio comune.
È stata la recente pandemia a fare da specchio e a svelare in che tipo di società realmente viviamo: una società della sopravvivenza, in cui l’allungamento della vita diventa lo scopo principale.
La pandemia ha avuto la “colpa” di rendere di nuovo visibile la morte meticolosamente rimossa, ha mostrato il vero volto dell’algofobia, la tanatofobia (4) che spinge la società a scarnificare la vita sempre di più, riducendola alla mera sopravvivenza.
Dinnanzi alla pandemia, la società della sopravvivenza vieta anche le messe: i sacerdoti attuano il “distanziamento sociale” e indossano le mascherine, sacrificando completamente la fede sull’altare della sopravvivenza.
Come scrive Han:
«In chiave paradossale, l’amore per il prossimo si manifesta come una presa di distanza. Il prossimo è un potenziale infetto. La virologia esautora la Teologia» (5).
La società dominata dall’isteria della sopravvivenza è una società di non morti: «siamo troppo vivi per morire e troppo morti per vivere» (6). Secondo Han il virus ci assomiglia, essendo una creatura non morta che si limita a moltiplicarsi, quindi a sopravvivere, senza vivere.
La crescente perdita di empatia deriva proprio dal fatto che l’Altro (7) sta scomparendo, viene reificato, diventando un oggetto perché l’Altro, in forma di oggetto, non fa male: nel tempo della pandemia, il dolore delle altre persone scompare in lontananza, non ci tocca a livello personale, si disperde nel numero dei casi; così facendo il distanziamento sociale diventa a tutti gli effetti un distanziamento mentale, perché l’alterità viene vista come portatrice pericolosa di un virus mortale e quindi da evitare.
È evidente, però, come il dolore non possa essere sconfitto, «sono sì bandite le ombre più crude, ma in compenso una luce diffusa penetra negli spazi. Il dolore viene sparso in ogni dove in forma diluita» (8): la prova è l’epidemia di dolori cronici presenti nella società in cui viviamo.
Nel momento in cui il dolore viene occultato e costretto a tacere, anestetizzato da analgesici metaforici e non, si ripresenta poi in forma molto più aggressiva, come testimoniano i molti casi di comportamenti auto-aggressivi, messi in atto nel tentativo di constatare di essere ancora viventi.
L’algofobia si traduce così in un’algofilia (9) incontrollata.
Questo incremento di casi di auto-lesionismo non è altro che un disperato tentativo dell’Io di percepirsi: provo dolore quindi sono.
Gli sport estremi e i comportamenti a rischio sono solo tentativi di sincerarsi della propria esistenza, «per cui la società palliativa, paradossalmente, crea estremisti. Senza la cultura del dolore nasce la barbarie» (10).
Tutto questo accade perché è il dolore che fa sì che lo spirito si formi e che si trasformi.
Non a caso tutte le più grandi trasformazioni sono dolorose:
«lo spirito conquista la propria verità assoluta solo a condizione di ritrovare se stesso nella disgregazione assoluta. Il suo potere si manifesta solo quando guarda in faccia il negativo e soggiorna presso di esso» (11).
Il dolore consente, se vissuto consapevolmente, un cambio di paradigma: non più segno di debolezza, ma di forza, non più ferita da nascondere o da tenere a bada, ma da mostrare senza vergogna.
Le pesanti conseguenze della sua cancellazione dalle nostre vite sono espresse nel capoverso finale del libro di Han:
«la vita priva di dolore e munita di costante felicità non sarà più una vita umana. La vita che perseguita e scaccia la propria negatività elimina se stessa. La morte e il dolore sono fatti l’uno per l’altra. Nel dolore, la morte viene anticipata. Chi vuole sconfiggere ogni dolore dovrà anche abolire la morte. Ma una vita senza morte né dolore non è umana, bensì non morta. L’essere umano si fa fuori per sopravvivere. Potrà forse raggiungere l’immortalità, ma al prezzo della vita.» (12).
- Byung-Chul Han, La società senza dolore, Einaudi, Torino 2021-2022, p.5.
- Algofobia: paura del dolore che porta alla sua rimozione forzata da ogni ambito della vita personale e sociale.
- Ivi, p.7.
- Tanatofobia: paura della morte.
- Ivi, p.20.
- Ivi, p.22.
- Si è qui utilizzato il maschile sovraesteso in “Altro” in quanto indicante il concetto di “chiunque sia altro-da-sé”.
- Ivi, p.35.
- Algofilia: senso morboso di piacere e di soddisfazione provocato dalla sofferenza fisica (propria o altrui).
- Ivi, p.42.
- Ivi, p.49.
- Ivi, p.72.
Un’altra cena rovinata
25 Luglio 2024Blanchard vs. Blanchard: un matricidio moderno
21 Luglio 2024Il fascino moderno dei vampiri
14 Luglio 2024
-
Riet Wijnen: conversazioni tra Arte, Filosofia e Attivismo
16 Febbraio 2022 -
La visione olistica di Ildegarda Di Bingen
21 Gennaio 2024 -
Chi ha ucciso Laura Palmer?
10 Gennaio 2020
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy